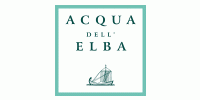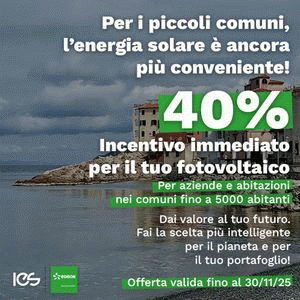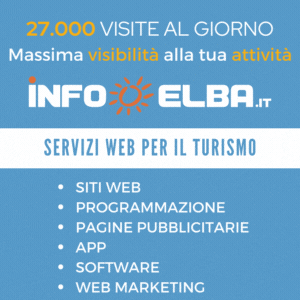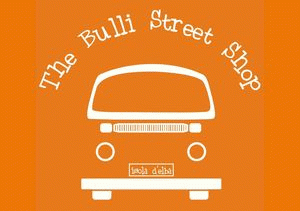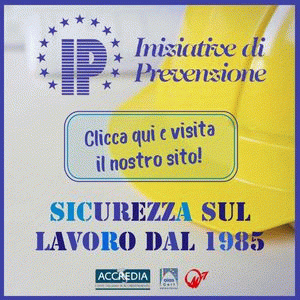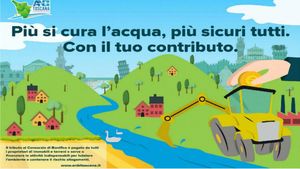Tra il 1857 e il 1859 furono apportate alcune migliorie alla laveria di Rio. Secondo Pietri però anche questi interventi non valsero a molto, poichè il risultato era “alla meglio un poco di puletta (sempre, però, fangosa)”, e così nel luglio 1859 l'impianto fu dismesso. Malgrado i fallimenti Pietri riconosceva lo sforzo del progettista, l'ingegner Theodor Haupt: “Qualora il Sig. Haupt abbia commesso degli errori nel progetto dei suoi lavori e abbia fatto spendere molti denari inutilmente alla Cointeressata, pur nonostante, coll'avere introdotto colla sua laveria o bene o male il sistema delle lavature delle gettate, si può asserire che ha riparato al danno fatto e che ha salvato dalla rovina l'Amministrazione, poiché è incontrastabile che, se non fosse stata la lavatura delle gettate, l'Amministrazione col solo andante non si sarebbe potuta reggere e sarebbe inevitabilmente fallita”. L'autore aggiunge che i riesi arrivarono a chiamare la laveria con un derisorio “la Magnifica”, che secondo Gianfranco Vanagolli fu così conosciuta dalla popolazione e non dalle maestranze.
Così nel giugno 1859 la laveria di Rio iniziò a essere profondamente ristrutturata. Del lavoro si interessò l'ingegner Auguste Ponsard. Per prima cosa fece realizzare un nuovo bottaccio più capiente, rifornito dallo stesso gorile della valle dei Mulini. “Da questo bottaccio”, scrive Gastone Garbaglia, “a mezzo di tubi di ferro si arrivava ad un grande cassone rettangolare in legno che veniva riempito di terre ferrifere. A 55 centimetri dal fondo del cassone e sopra il livello delle terre, veniva posata una prima griglia di filo di ferro e quindi una seconda griglia più fine, di filo d'ottone. Un operaio poi, maneggiando una manovella, apriva e chiudeva il rubinetto sulla conduttura dell'acqua dimodoché questa entrava ad intervalli e con violenza nel cassone al disotto delle griglie agitando in tal modo le terre e provocando la separazione dell'argilla che sfuggiva con l'acqua attraverso le griglie, lasciando sul fondo del cassone il minerale lavato. In seguito questo veniva scaricato e preparato l'apparecchio per una nuova operazione”.
La nuova laveria funzionava decisamente meglio della precedente, tanto che fu ingrandita, aggiungendo due cassoni in ghisa anziché in legno, perché garantissero maggiore durata. L'acqua veniva scaricata nella valle di Riale, per fluire in mare. Questo miglioramento fu solo il primo di una serie: Rio Marina non poteva privarsi di una laveria al passo con i tempi, dato l'ormai irrinunciabile processo di lavaggio del minerale per un'attività efficiente. Così negli anni seguenti la crescente richiesta di minerale lavato da parte dei compratori esteri costringerà Ponsard a migliorare e incrementare il processo di lavaggio. Fu quindi progettata una nuova laveria più moderna: i lavori iniziarono l'11 agosto 1863 e l'impianto entrò in funzione il 14 novembre 1866. Ponsard la chiamò Grand Patouillet (dal nome del suo inventore), ma i riesi la italianizzeranno in “pattugliè”. Con essa la produzione di lavato arrivò a toccare le 10/15 tonnnellate l'ora, una quantità di tutto rispetto. Resti di essa sono ancora visibili nel cantiere Bacino.
L'innovazione tecnica di Ponsard consisteva nel frantumare il minerale e agitarlo a grande velocità nell'acqua, affinché la parte terrosa rimanesse in sospensione e venisse scaricata con il liquido, lasciando solo il minerale pesante. Per la descrizione dell'impianto, la parola a Garbaglia: “Per questo ideò di costruire un gran vascone lungo otto metri, a sezione semicircolare lungo l'asse longitudinale del quale, appoggiata sulle pareti di testa, girava una grossa gabbia formata da sei dischi di ghisa di circa un metro di diametro i quali, oltre ad essere riuniti dall'asse centrale, erano collegati mediante degli sbarroni di ferro quadro fissati a distanze uguali sull'orlo esterno. Questi sbarroni erano leggermente piegati nel senso longitudinale in modo che passando da un disco all'altro avevano un andamento elicoidale. Tra il fondo della vasca ed il filo esterno della gabbia restava uno spazio di circa 15 centimetri. Per lavare, dopo aver messo in movimento il gabbione facendolo girare sull'asse longitudinale e riempito il vascone, scendendole da una tramoggia, le terre che precipitavano sul fondo del vascone ed arrivate ad un certo spessore venivano investite dagli sbarroni in movimento i quali, oltre a spappolarle le facevano avanzare verso l'estremità opposta del vascone dove veniva immessa di continuo una grande quantità di acqua. Le torbe invece uscivano traboccando per sfioramento dalla stessa estremità ove si introduceva la terra. Ne veniva di conseguenza che il materiale, oltre ad essere spappolato ed agitato fortemente veniva, man mano che si separava dall'argilla, portato incontro a dell'acqua chiara e sempre tenuto in movimento riusciva molto bene lavato. All'estremità del vascone, con un sistema di tazze [erano 12, anch'esse in ghisa] fissate su una raggera che girava insieme al gabbione, il materiale veniva sollevato e scaricato all'esterno. Per azionare questo macchinario fu necessario fare un impianto di caldaie a vapore con il relativo apparecchio motore e per fornire l'acqua ad esso necessaria si dovette installare una stazione di pompe, funzionanti anch'esse a vapore, vicino alla spiaggia per prelevare l'acqua del mare giacché, nella quantità necessaria, l'acqua dolce era impossibile trovarla”.
Nel 1877, ci dice l'ingegner Fabri, a Rio erano attivi due patouillets, oltre a quello descritto l'altro doveva essere a Vigneria, anche se ne viene segnalato uno sopra la galleria di Santa Barbara (anche se questo potrebbe essere il Gran Patouillet di Ponsard). Fabri aggiunge: “I lavatoi sono posti al piede delle gettate e all'altezza d'una ventina di metri sul mare. L'acqua vi è mandata per mezzo di pompe, che sono messe in moto da macchine a vapore come i patouillets”. Un patouillet fu costruito anche sulla punta di Rio Albano. Tuttavia Fabri dice che a Rio il sistema a bottaccio alimentato da fossi e sorgenti, visto in precedenza, per il lavaggio del minerale non era ancora stato abbandonato. E addirittura era usato, sebbene in piccola parte, anche un lavaggio rudimentale del minerale con l'acqua dei fossi, per poi raccoglierne il minuto o puletta.
Nel 1897 il direttore delle miniere Cortese progettò e sperimentò un nuovo sfangatore “a getto diretto”. Ne furono installati almeno tre, ma si mostrarono inefficaci, tanto che pochissimi anni dopo furono dismessi. È lo stesso progettista a illustrare il loro funzionamento: “L'edificio costruito sul fianco di una pendice consiste in un masso di muratura in terra e mattoni, sul quale si creano delle doccie lunghe m. 3,50, larghe, all'origine, m. 1,20 e ristrette alla bocca, a 0,60 e, aventi due diverse inclinazioni, alla parte superiore lunga 1 metro, e alla seguente, lunga 2,50. Le doccie sono rivestite di piattine di ghisa, e separate fra di loro da muretti fatti a becco, come le pile di un ponte. Ad ogni canale o doccia, corrisponde un sistema di due tubi, fatti a proboscide, che lanciano dei getti d'acqua a forma di stretto ventaglio. L'acqua arriva dal tubo A, e si divide in modo da formare un grosso getto dal tubo B, ed uno più piccolo, ma più violento che, urtando sul fondo della doccia, si apre a ventaglio dal tubo C. Il getto superiore investe il minerale D, dove è gettato dai vagoncini che lo portano dalle gettate, lo spappola, lo disgrega e lo fa scendere sotto forma di acqua fangosa e ciottoli: il getto C, tenta di arrestare questa pasta che scende, finisce lo sfangamento, e il minerale cade coll'acqua in E, dove si arresta, mentre l'acqua fangosa continua a correre ed è costretta nel rivo vicino, opportunamente disposto a bacini, a mezzo di briglie, e là deposita la puletta. Di tali lavaggi se ne sono impiantati due, uno a Vigneria, con due doccie, servito da una pompa Tangyes, che solleva 90 metri cubi all'ora, e uno alla Miniera di Rialbano, con quattro doccie, servito da una pompa che solleva 120 metri cubi all'ora di acqua di mare”.
Con il nuovo secolo le laverie vedranno ulteriori miglioramenti, grazie soprattutto all'impiego dell'elettricità nelle miniere isolane.
Andrea Galassi