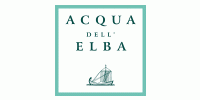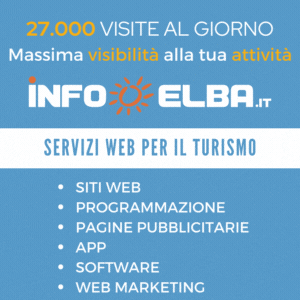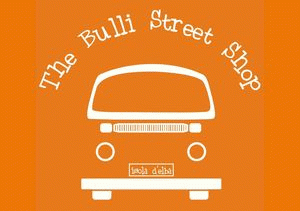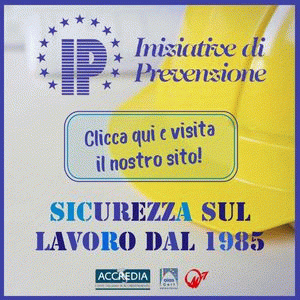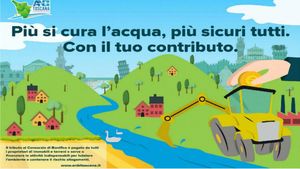Sono arrivate le rondini. L’ Elba ti avvolge con i profumi, i colori e la luce della primavera. E’ tempo di tornare. Quando la nave, doppiato Capo Vita inizia a costeggiare l’Isola, da una sella fra il Monte Lentisco e la Piana della Martella, spunta una specie di pagoda orientaleggiante. E’ il Mausoleo Tonietti, un prezioso edificio legato alla storia delle miniere di ferro, e un capolavoro della architettonica eclettica di Adolfo Coppedè… come narrano anche le pagine di Wikipedia.
Oggi il Mausoleo, fra vandalismi, ruberie e abbandono, appare destinato alla rovina. Il monumento sorge nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, all’inizio della GTE, il cammino divenuto un classico nell’escursionismo internazionale, e che in una cinquantina di chilometri lungo le antiche vie montane, sale fino ai 1.018 m. della cima del Monte Capanne e scende al Calello di Pomonte, sul mare che guarda la Corsica. Qui, alla fine della GTE, ti attendono le opere di un altro grande artista: Giò Pomodoro, scolpite nel granito del Capanne.
Fino dal secolo passato sono stati numerose le denunce sul “vergognoso” stato in cui viene lasciato il Mausoleo e sono state ideate varie iniziative per il suo restauro. Tutte naufragate fra viscosità burocratiche e incertezze finanziarie. Oggi ci stiamo avvicinando al punto di non ritorno, così che un altro segno della cultura materiale elbana si trasformerà in un dimenticato “cumulo di sassi”.
La sezione di Italia Nostra dell’Arcipelago Toscano ha lanciato, nell’ autunno passato, una nuova campagna di sensibilizzazione nel tentativo di salvare il Mausoleo dalla rovina alla quale sembra tristemente destinato. Dobbiamo sfatare questo destino. Dobbiamo essere consapevoli che, se il restauro del Mausoleo Tonietti, è in grado di portare indubbi benefici al “Sistema Elba”, dall’ altra il suo abbandono al degrado comporta marcate ricadute negative per quel turismo esperienziale, fra cultura e natura, sempre più richiesto e pubblicizzato. L’ offerta ecoturistica, è un punto qualificante della Carta Europea del Turismo sostenibile, promossa con successo crescente dal PNAT, ed in linea con le primarie finalità di utilizzo previste per i ricavi della tassa di sbarco: un tesoretto di diversi milioni di euro che nel restauro del Mausoleo, stimato in un centinaio di migliaia di euro, troverebbe un idoneo e strategico investimento. Ricordiamoci sempre che il battito delle farfalle da Cavo a Pomonte, passando per il Monte Perone, si sente in molti luoghi del nostro Paese e dell’ Europa intera.
Dal Mausoleo, i boschi di lentisco, le leccete e le pinete, coprono le pendici dei monti e scendono fino alla Costa dei Cancherelli segnata dalla presenza di strati rocciosi giallastri, che si appoggiano e ammantano i grigi calcari del substrato.
Sono i resti di antiche dune costiere, dette eolianiti, formate da sabbie, ghiaie minute e frammenti di conchiglie, cementate da carbonato di calcio, erosi dal mare che ha scolpito selettivamente la superficie delle dune creando buchette e piccoli solchi dai bordi taglienti.
Il nome di eolianiti, sta ad indicare il ruolo che ebbe il vento nella loro formazione, come accade ancora oggi a Lacona dove resiste l’ultima porzione di quei cordoni dunali che da 5-6 mila anni fa fino al XIX-XX secolo, coronavano le spiagge di Campo, Procchio, Biodola, San Giovanni e Mola, e separavano l’ambiente marino dalle lagune e stagni costieri delle piane interne.
A Lacona, favorite dalla bassa vegetazione e dagli interventi realizzati dal Parco Nazionale per contenere l’erosione, si accumulano i granuli di sabbia mossi dalla spiaggia e trasportati dai venti dei quadranti meridionali. A Mola, resiste ancora l’unica zona umida rimasta all’ Elba, dove un percorso di passerelle e torrette allestito dal Parco Nazionale, permette la corretta fruizione del luogo e l’osservazione della ricca avifauna migratoria e stanziale che lo frequenta. Il Parco inoltre ha creato a Lacona un Centri di Educazione Ambientale (CEA), e a Mola, l’Aula Verde e Blu, gestita da Legambiente, dove sono molteplici le iniziative che illustrano le caratteristiche e i valori ecosistemici legati alle dune costiere e alle aree umide.
Antichi depositi di natura eolica sono presenti, oltre che alla Costa dei Cancherelli, in vari punti lungo la fascia costiera dell’ Elba centro orientale ( Viticcio, Scaglieri, Biodola, Valle di Lazzaro, Monte Capo Stella, costa occidentale di Calamita), ma sono quelli che affiorano fra la Cala dei Cancherelli e la Cala Mandriola a Cavo, e quelli che dalla Punta di Barabarca arrivano alla spiaggia di Santa Maria a Capoliveri e risalgono per quasi un centinaio di metri fino al Santuario della Madonna delle Grazie, che ci danno le più ricche informazioni sulla storia geologica, climatica e antropica dell’Elba.
Le antiche eolianiti si estendono per vari metri anche sotto la superficie marina, indicando che la loro formazione risale a degli stadi di basso stazionamento del mare. Intercalati ai depositi sabbiosi si trovano livelli di paleosuoli argillosi e arrossati dalla ossidazione del ferro, dove è segnalata la presenza di strumenti litici musteriani. Le datazioni al carbonio 14 sui paleosuoli delle dune di Cavo e Capoliveri , indicano età attorno a 48 e 19 mila anni fa corrispondenti, nella scala dei tempi geologici, al tardo Pleistocene superiore, e in quella antropica al Paleolitico medio/superiore. Questi dati ci riportano alle ultime fasi della glaciazione del Wurm, quando il mare da un livello di 60-70 metri sotto l’attuale, giunse, all’ acme del periodo glaciale attorno a 20.000 anni fa, fino ad uno stazionamento negativo di 120-130 metri.
L’Isola d’Elba era parte di una vasta e pianeggiante penisola, spazzata dai venti, che includeva anche Pianosa e che al procedere del raffreddamento climatico giunse a lambire la Capraia. Resti fossili, ritrovati nella celebre Grotta dell’ Orso che si apre a Porto Azzurro lungo il Rio Reale, indicano che la penisola elbana aveva ospitato inizialmente rinoceronti ed ippopotami e poi, al calare delle temperature una associazione faunistica costituita da orsi, cervi, caprioli, lepri, cinghiali. Una ricca selvaggina per i cacciatori paleolitici che hanno lasciato i segni più evidenti del loro passaggio a Lacona e Procchio e piccole tracce nei suoli delle eolianiti di Cavo e Capoliveri, dove i nostri antenati accesero i loro fuochi.
Erano gli ultimi gruppi di neanderthal che da oltre centomila anni vivevano in Toscana, lasciando i loro resti fossili dalle Apuane alla Maremma. I neanderthal attorno a 40 mila anni fa si estinsero, più o meno con l’ arrivo dei sapiens, giunti nelle nostre terre, come ci dicono gli archeologi, provenendo dalla Francia, percorrendo la pianeggiante fascia costiera ligure. E ’ragionevole ritenere che per alcuni migliaia di anni neanderthal e sapiens abbiano condiviso un habitat comune intrecciando così il loro percorso evolutivo. Resta il fatto che ricerche di paleoantropologia portano ad indicare che, noi sapiens toscani, siamo portatori di un genoma che contiene geni di neanderthal del 4%, fra i più elevati del mondo.
Passato, il picco glaciale attorno a 20 mila anni fa, le temperature del globo iniziarono a salire; la morsa dei ghiacci si allentò e il mare inizio a risalire le coste della penisola elbana finchè,… attorno a 12 mila anni fa, proprio quando nella scala del tempo geologico e climatico il Pleistocene finisce ed inizia l’ Olocene, e il periodo interglaciale che stiamo vivendo, Capraia e Pianosa prima e l’ Elba poi si staccano del continente, e acquistano la loro insularità. Al tempo nei territori della Mezzaluna fertile del Vicino Oriente, inizia il Mesolitico, il momento di passaggio fra i sapiens cacciatori e raccoglitori del Paleolitico e i sapiens agricoltori ed allevatori del Neolitico. Le frequentazioni umane nelle isole si interrompono, e solo attorno a 8 mila anni fa i primi naviganti del Neolitico, tornano a frequentare l’ Elba, lasciando i loro evoluti strumenti di selce, ossidiana e serpentino, in vari luoghi dell’ Isola. Poi attorno a 4 mila anni fa, durante l’ Eneolitico , una colonia di Rinaldoni maremmani si stabilì nella Grotta di San Giuseppe , una vasta cavità carsica in una montagnola calcarea , aperta in prossimità di quei sink-hole che da anni si aprono, guarda caso, nella Piana di Rio. I Rinaldoni di San Giuseppe, giunti nelle nostre contrade alla ricerca di minerali, sono i primi Elbani. I loro resti e i loro manufatti, in rame, osso e ceramica sono conservati nel Museo Archeologico di Rio, mentre la Grotta, uno dei più importanti siti italiani dell’ Età del Rame, rimane dimenticata in un triste e colpevole abbandono. Poi nei primi secoli del primo millennio A.C. all’ Elba giunsero le conoscenze sulla metallurgia del ferro e l’ Isola…
A questo punto mi sono sentito chiamare. Era un mio vecchio e caro amico Cavese. Un abbraccio e poi:
“Proprio te! Mi dici perché la Cala dei Cancherelli si chiama così?”
E il Cavese disse:
“Nel vernacolo elbano il canchero era il vaso da notte, l’orinale, e con cancherelli si chiamavano in genere i piccoli vasetti. Per questo da sempre le rocce della Cala dietro il Capo, solcate da taglienti buchette, prendono quel nome. Ricordo quando ancora bambolo, nell’ immediato dopo guerra, accompagnavo babbo, a prendere il sale che rimaneva nei cancherelli della Cala. Camminavo sempre scalzo ed era un classico che tornassi a casa con i piedi sanguinanti. Altri tempi!”
Beppe Tanelli