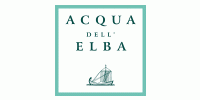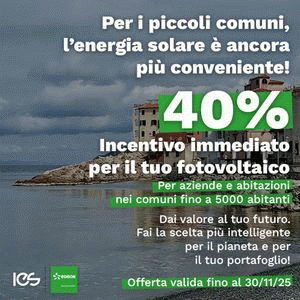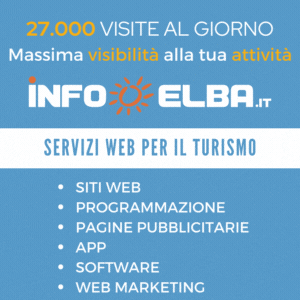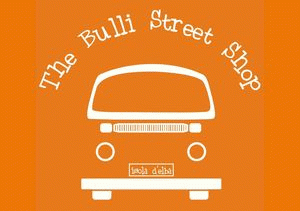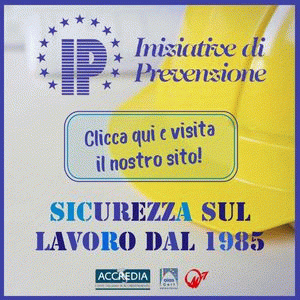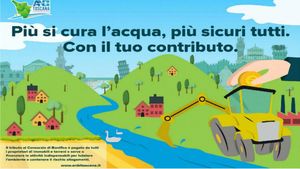«Il fascismo di provincia non fu meno sporco di quello delle capitali. Fu solo più sfacciato, più domestico, più impunito.»
Sono passati ottant’anni dal 25 aprile 1945. Ma prima ancora della Resistenza armata, ci fu un’altra forma di resistenza, nei gesti ostinati di chi rifiutò di piegarsi, anche solo con una penna, anche solo con una denuncia, in un tempo in cui dissentire era già un atto di coraggio.
Questa storia prende forma tra i carteggi conservati all’Archivio di Stato di Livorno, dove ho cercato di ricostruire, documento dopo documento, il volto del potere locale all’Isola d’Elba durante il Ventennio. Un potere che assunse forme diverse, a seconda dei luoghi, dei contesti, delle persone.
A Portoferraio, quel potere ebbe un interprete assoluto: Epaminonda Pasella, podestà e plenipotenziario, figura centrale di un’amministrazione in cui lo Stato, il Partito e l’interesse personale tendevano a sovrapporsi.
Uno dei suoi maggiori oppositori, Mario Gasparri, imprenditore elbano, che in un regime dove molti tacevano, scrisse, denunciò, sfidò. Lo fece con strumenti limitati, da dentro il sistema.
Chi era Epaminonda Pasella?
Epaminonda Pasella fu il massimo rappresentante del fascismo ferajese (ed Elbano) per circa due decenni, dagli albori del Fascio locale nei primi anni Venti fino alla sua rovinosa uscita di scena, tra il luglio e l’agosto del 1943. Nato a Piombino nel 1875, fratello minore di Umberto – tra i fondatori con Mussolini del movimento nel 1919 – Epaminonda scelse una via diversa: restare sull’isola e costruirvi un potere personale assoluto, capillare, duraturo.
Massone e reduce della Grande Guerra come ufficiale della Regia Marina, fu legato da profonda amicizia a Costanzo Ciano, al quale rimase politicamente fedele. Squadrista, sindaco di Portoferraio e poi unico podestà (1926-1943), fu anche segretario politico del fascio cittadino, triumviro, presidente della federazione elbana, supervisore dell’ONB e gestore occulto – secondo documenti dell’epoca – dei principali interessi economici e commerciali del porto. La sua figura incarna perfettamente il modello di regime descritto da Palla e Giovannini nel saggio ‘Il fascismo dalle mani sporche’: uno Stato che si fa strumento di interessi personali, dove le cariche pubbliche diventano leve di influenza e i confini tra amministrazione e affari svaniscono. Pasella governava in modo pervasivo: regolava le concessioni, distribuiva incarichi, si intrometteva nei contratti, influiva persino sulle licenze di commercio e sulla gestione del trasporto marittimo.
L’affarismo come stile di governo
Il caso più clamoroso è la gestione del porto di Portoferraio, trasformato da Pasella in una cassa di controllo e pressione sugli imprenditori locali. Le tariffe venivano alterate a piacimento; le concessioni, date o negate in base alla fedeltà politica; le cariche, distribuite come premi di clientelismo.
Il nome più ricorrente tra i suoi oppositori fu quello di Mario Gasparri, titolare di attività vinicole e commerciali, che più volte si ribellò al meccanismo.
Gasparri fu una spina nel fianco del regime locale. E lo fu scrivendo lettere, esposti al prefetto, alla segreteria del partito, fino ad arrivare – fatto clamoroso – a indirizzare una lettera personale a Benito Mussolini, in cui accusava Pasella di trasformare il fascismo in racket personale.
Gasparri era iscritto al PNF, come la maggior parte di coloro che volevano fare impresa durante il Ventennio. Si oppose scegliendo la via della parola e della denuncia, con coraggio, all’interno di un sistema repressivo.
Nel mirino dei suoi esposti vi era soprattutto l’uso sistematico e arbitrario della macchina pubblica per colpire non solo i dissidenti politici, ma anche quei cittadini che si trovavano in conflitto con gli interessi economici dei potenti. Gasparri ad esempio, si lamentava che le contravvenzioni imposte alla sua azienda enologica – per dazi e imposte di consumo – fossero costruite ad arte, con intento punitivo. Al centro delle sue accuse vi era il conflitto d’interessi tra incarichi pubblici e vantaggi privati: Gasparri denunciava come Pasella sfruttasse la propria posizione per influenzare dinamiche economiche strategiche, traendo beneficio da un intreccio opaco tra autorità politica e interessi commerciali personali.
Pur sconfitto in sede giudiziaria nel 1937, Gasparri lasciò una traccia evidente: la sua fu una resistenza civile, solitaria ma limpida, che anticipò con grande lucidità il fallimento morale di un’intera gestione del potere.
Le rappresaglie politiche
Per tutta risposta, Pasella usò la macchina statale per perseguitarlo. Le pressioni si moltiplicarono: ispezioni fiscali mirate, contravvenzioni ripetute, allusioni pubbliche, tentativi di screditamento e campagne di diffamazione, culminate nelle accuse indirette ma inequivocabili lanciate da Pasella nelle sue ultime lettere ufficiali. Il Commissario di P.S. Pachino, in una nota riservata del 1938, scriveva: «Molte delle accuse a carico del Gasparri paiono di chiara origine persecutoria, e in più di un caso ispirate direttamente dall’ufficio del podestà».
Nonostante ciò, Gasparri non tacque mai e lo sfidò apertamente. Qualcosa ottenne: i superiori di Pasella, irritati dal clamore della vicenda, gli revocarono alcune cariche secondarie già a metà degli anni ’30. Ma il processo si concluse con il rigetto delle accuse, e Gasparri fu persino condannato al pagamento delle spese legali. Tuttavia, a modo suo, insegnò che anche nel regime più chiuso esiste spazio per il dissenso.
Il crollo
Nel 1943, la situazione precipita. Portoferraio è stanca e prossima a immani tragedie. Il malcontento cresce, il clima si fa teso. I fascisti locali sono isolati. Le forze dell’ordine segnalano l’urgenza di un cambio di potere.
È del 6 agosto 1943 la lettera del Prefetto Romualdi in cui si chiede ufficialmente la sostituzione di Epaminonda Pasella per motivi di ordine pubblico. A Pasella fu intimato di dimettersi, in forma di invito irrevocabile, per non aggravare ulteriormente una situazione già esplosiva. Lui obbedì, ma con riluttanza.
Nello stesso giorno, congedandosi dal municipio, inviò una lunga lettera al Prefetto. In essa allegò un memoriale autocelebrativo dei suoi vent’anni di amministrazione e, non senza amarezza, dichiarò che avrebbe voluto «rimanere al mio posto almeno fino alla Vittoria».
Lo sputo
Nel frattempo, nella calura estiva dei ‘quarantecinque giorni’, Gustavo Damiani, ufficiale di Marina, lo affrontò pubblicamente e gli sputò in faccia. Un gesto semplice. Di disprezzo, ma anche di giustizia. La piazza restò in silenzio. Nessuno lo difese. Nessuno lo condannò. Tutti compresero. Nessuna rappresaglia. Solo uno sputo. Jacopo Broccardi, nominato commissario prefettizio il 7 agosto, prese il suo posto. Ironia della storia: era lo stesso uomo che vent’anni prima Pasella aveva spodestato in camicia nera.
Qualche giorno dopo, il settimanale locale Il Popolano pubblicò una nota glaciale:
«Parce Sepulto» - «Né un fiore. Né una lacrima».
Nella sua lettera di commiato, Pasella non mancò di colpire ancora i suoi nemici, seppure in modo indiretto. Dopo aver giurato, con un certo opportunismo, fedeltà al governo Badoglio – di cui si disse «entusiasta ammiratore» – passò a denigrare, tra i molti, ancora il suo oppositore più tenace, Gasparri: «alcuni evasori del fisco […] frodatori del pubblico erario, dei quali uno si aggirava per la città come un cittadino ‘cospicuo’».
Non potendo più restare a Portoferraio, anche su pressione dei familiari, si trasferì in Piemonte, dove morì d’infarto a Novara, il 25 gennaio 1945.
Il fascismo non fu solo manganello e olio di ricino, ma anche potere locale distorto, affarismo istituzionalizzato, vendetta e clientelismo.
E come Epaminonda, ce ne furono tanti.
E come Gasparri, pochi.
Enrico Manzi
Post scriptum
Raccontare Pasella in poche righe è difficile. A lui ho dedicato un intero capitolo della mia tesi di laurea, composto da circa 20 pagine di documentazione, lettere, note d’archivio e contributi opportunamente citati. E, come sempre, si ha l’impressione di trovarsi di fronte solo alla punta di un iceberg.
Chiunque voglia approfondire, può leggere il capitolo 2.6 completo sulla pagina di Academia.edu, dove è consultabile ‘Fascismo e Antifascismo all'Isola d'Elba. Fatti e personaggi’. (https://independent.academia.edu/EnricoManzi ).
Perché il fascismo, anche nei suoi piccoli gerarchi locali, non fu solo un’ideologia: fu una pratica quotidiana di potere, di affari, di persecuzioni.
E forse, proprio per questo, il suo spettro continua a resistere – silenzioso ma presente – ovunque vi sia un politico che confonde l’ufficio pubblico con il proprio tornaconto, anche nei piccoli comuni, anche nel Secondo Dopoguerra, anche oggi.