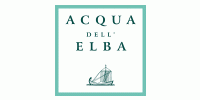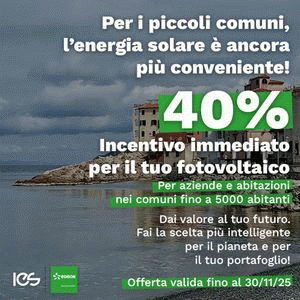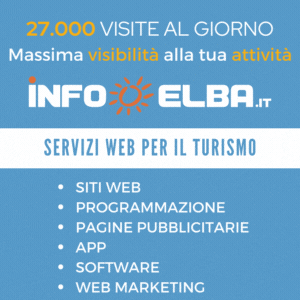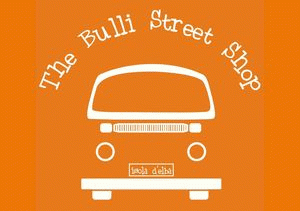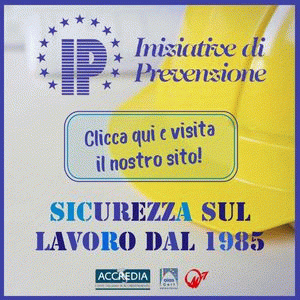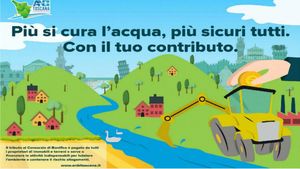La possibilità di rilevare odori è di basilare importanza per la sopravvivenza stessa degli animali, Homo sapiens compreso. Basti pensare ai molteplici utilizzi in natura del senso dell’olfatto, a partire dall’individuazione di fonti alimentari fino al riconoscimento di situazioni di pericolo, senza dimenticare fattori intermedi quali il piacere spirituale offerto dai profumi che ci circondano. Proprio questo ampio spettro di utilizzi ha indotto gli scienziati a studiare metodi e sistemi per creare un naso artificiale, cioè uno strumento in grado di rilevare e riconoscere gli odori.
Cominciamo con una definizione che aggiorneremo poco più avanti: il naso elettronico è un sistema “biomimetico”, progettato cioè per imitare il funzionamento dei sistemi olfattivi che ritroviamo in natura come quello dei mammiferi o più specificatamente quello umano.
Storicamente il primo sistema di questo tipo risale al 1961 per rilevare la presenza di acetone, seguito a breve da molti altri dedicati a sostanze diverse, fino ai nostri giorni quando gli strumenti sono accoppiati a sistemi di riconoscimento sofisticati anche con ausilio di reti neuronali ed intelligenza artificiale.
Negli animali l’olfatto, cioè il senso deputato alla percezione degli stimoli odorosi, si basa sull’interazione di tre attori principali: il naso, la cui mucosa è in grado di recepire gli stimoli olfattivi, le cellule che trasportano questi stimoli e il cervello che li decodifica trasformandoli in “percezione”.
Il naso elettronico ha la medesima struttura ed è composto da: un array di sensori elettronici (naso), un processore digitale che riceve i segnali da essi, li elabora e li memorizza (cellule), un sistema di riconoscimento software (cervello). Il tutto è schematizzato nella Figura 1:

Figura 1. Parallelismo fra sistema olfattivo animale e artificiale.
In realtà il problema è tutt’altro che semplice poiché, anche se sembra clamoroso e strano, l’odore in quanto tale non esiste. Infatti ciò che avviene in realtà è che una molecola si lega ai recettori olfattivi nel naso, i quali trasformano il segnale chimico in un segnale nervoso, che arriva al cervello dove le informazioni vengono integrate e forniscono “una percezione”: l’odore.
Il sistema nel regno animale funziona benissimo ed è così sofisticato e diversificato nelle specie da permettere la corretta rivelazione di ampi spettri di odori, da quelli più spiacevoli come le emanazioni di una puzzola a quelli più gradevoli come il profumo di un fiore. Alcune specie poi hanno particolari predisposizioni per un’elevatissima sensibilità, in grado di far loro percepire la presenza di certe molecole anche se presenti in bassa quantità (il classico esempio è l’olfatto dei così detti ‘cani molecolari’).
Nel regno artificiale, per usare un parallelismo, il naso non esegue un’analisi chimica dell’odore rilevato né è in grado di identificarne la composizione (per questo esistono altri strumenti come lo Spettrometro di Massa) bensì il suo insieme di sensori produce una cosiddetta “impronta olfattiva”.
Questo è un punto fondamentale e va compreso a fondo se si vuole inquadrare correttamente il naso elettronico nel panorama dei sensori e biosensori. Nella quasi totalità di questi ultimi, infatti, si cerca con ogni sforzo di massimizzare quella caratteristica detta “specificità”, vale a dire la capacità di rilevare uno ed un solo elemento chimico, biochimico, biologico o fisico, senza subire disturbi e “falsi positivi” da altro. Ad esempio, un biosensore per la rilevazione di un particolare antigene nel sangue è capace di discriminare fra la sua presenza e quella di miriadi di altri antigeni, dai quali la misura non è minimamente alterata.
Nel caso del naso elettronico invece, proprio perché deputato a rilevare qualcosa che “non esiste”, il sistema non può per definizione essere altamente specifico. Lo sono, ciascuno per una ben precisa grandezza, gli N sensori che costituiscono lo “Electronic sensor array” di Figura 1. Ciascuno di essi genera un segnale che preso da solo non permetterebbe certo l’individuazione di un odore. Gli N segnali insieme costituiscono invece un elaborato insieme grazie al quale l’impronta olfattiva può essere discriminata e classificata, sia mediante un database di riferimento (acquisito in una preliminare fase di addestramento), sia addirittura con l’ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale.
Una conseguenza di questo approccio è che un naso elettronico è costruito appositamente per rilevare un ben preciso odore (o al massimo pochi odori), a differenza del naso animale che, come detto più sopra, funziona su un range enorme e articolato.
Pur con questa limitazione, è fondamentale che l’array di sensori possieda alcune caratteristiche: una buona sensibilità verso le singole sostanze di interesse, distinte specificità individuali, velocità di risposta ragionevole (qualche minuto al massimo), riproducibilità e stabilità nel tempo. Le “singole sostanze di interesse” devono comprendere il più possibile elementi distintivi presenti nei corpi il cui odore si desidera rilevare, come ad esempio le sostanze di Figura 2 che sono distintive di due tipi di frutta:

Figura 2. Esempio di molecole distintive degli odori di banana e pera.
Proprio per la varietà di molecole da rilevare nell’array, i sensori possono essere di diversa tipologia. Il più semplice è “a variazione di conducibilità” ed è costituito da una coppia di elettrodi metallici in platino, alluminio od oro serialmente connessi in modo che fluisca una corrente elettrica. Sugli elettrodi è depositato uno strato di materiale attivo costituito da ossidi metallici o polimeri conduttori. L’interazione delle molecole odorigene con il materiale attivo provoca una variazione di conducibilità elettrica rispetto ad una situazione di riferimento e permette la misura quantitativa del gas preso in esame, come schematizzato in Figura 3:

Figura 3. Trasduttore a variazione di conducibilità. Tra i due elettrodi funzionalizzati (in grigio) scorre una corrente elettrica modulata dalle molecole odorose che con essi interagiscono.
Così come il materiale attivo fa variare la corrente, alla stessa stregua può alterare la quantità di carica elettrica su una superficie. Grazie all’enorme sviluppo nel campo dei componenti elettronici, i sensori MOSFET sono figli diretti degli omonimi transistor e sfruttano proprio la variazione di carica su un elettrodo (chiamato ‘Gate’) per modulare la corrente che fluisce fra altri due elettrodi (detti ‘Source’ e ‘Drain’). La misura di questa corrente è funzione delle molecole del gas che interagiscono con la superficie del Gate. Un aspetto primario di questa tecnologia è il fatto che il dispositivo MOSFET “è” inerentemente un transitor e quindi ha la proprietà di amplificare i segnali. Ne consegue che una piccolissima variazione del campo elettrico di Gate genera una ben più grande e misurabile variazione nell’intensità di corrente fra gli altri due elttrodi, fornendo così un dispositivo più sensibile di quello conduttimetrico visto più sopra:

Figura 4. Struttura di un MOSFET, dispositivo a semiconduttore qui con Gate “esposto” che funge da sensore di gas modulando la corrente elettrica che scorre fra le zone verdi S e D.
Questi sensori, insieme ad ulteriori tipologie, appartengono a quella classe di dispositivi che non presenta una particolare specificità per uno o più odori, bensì contribuisce ad accrescere il database di “impronte odorose” da analizzare successivamente. Fra le altre tipologie di nasi di questa natura è doveroso citare quelli ottici e quelli basati su variazioni di massa. Nel primo caso l’interferenza di due fasci luminosi è alterata dalle molecole odorose mentre nel secondo caso queste si legano a molecole “link” precedentemente fissate sul sensore aumentando la massa complessiva presente.
Quando invece non si desidera mappare un odore, ma rilevarne uno ben preciso appartenente ad un gas noto, la soluzione vincente è rappresentata dai sensori elettrochimici. L’ovvia applicazione di essi è per generare allarmi in presenza di ben precisi gas pericolosi. Questi nasi elettronici contengono una terna di elettrodi e in particolare sul “sensing electrode” avviene la cattura delle molecole del gas penetrate attraverso una membrana porosa:

Figura 5. Struttura di un sensore elettrochimico. In giallo gli elettrodi “sensing” e “counter” tra cui si instaura il passaggio di cariche elettriche misurate riferendosi al potenziale del “reference electrode”.
I sensori elettrochimici sono molto specifici e quindi rispondono alla presenza di un solo ben preciso odore, ma al contempo sono quelli in assoluto più sensibili arrivando a rivelare la presenza di molecole gassose dell’ordine di poche parti per miliardo (ppb, part per billion).
Le applicazioni del naso elettronico stanno aumentando costantemente perché le nuove tecnologie ne riescono ad ottimizzare le performance.
Nel campo ambientale sono usati per l’identificazione e la quantificazione di inquinanti in acqua, aria e suolo quali il Diossido di Azoto, l’Ozono, il Monossido di Carbonio, il Diossido di Zolfo. Sono in grado di effettuare misure in continuo degli odori con la determinazione dell’impatto olfattivo e la generazione di allarmi a seguito del superamento di soglie, allo scopo di identificare in tempo reale situazioni potenzialmente critiche per la salute umana e animale in genere.
In ambito biomedicale le applicazioni sono agli inizi e si basano sul fatto che alcune patologie alterano l’odore delle persone che le possiedono, aprendo così la strada ad un innovativo strumento diagnostico. Ad esempio sono in corso studi per la prevenzione del tumore prostatico e di altre patologie urologiche attraverso l’analisi dell’odore dell’urina, oppure del tumore polmonare e di diverse malattie respiratorie attraverso l’analisi dell’odore del fiato espirato dal paziente.
In ambito alimentare la maggior parte degli aromi rende difficile la caratterizzazione precisa da parte di un umano e le persone in grado di operare in questo senso (dette “nasi assoluti”) sono rare e possono comunque lavorare per pochi minuti alla volta a causa della veloce assuefazione del nostro olfatto di fronte a nuove percezioni odorose. Le applicazioni sono davvero tante: dall’analisi della qualità del caffè a quella del vino, con determinazione dell’origine geografica del prodotto e riconoscimento di alterazioni; il controllo del processo di maturazione della frutta e delle verdure durante il loro periodo di conservazione (dalla raccolta al consumo); il controllo della freschezza e la prevenzione del deterioramento di materie prime e di prodotti alimentari, come frutta, carne e pesce; il controllo dell’autenticità del prodotto, ad esempio tartufo, formaggio parmigiano, grana padano.
Tutte queste diversificate applicazioni fanno ragionevolmente pensare che il naso elettronico vedrà nel futuro prossimo una grande evoluzione e costituirà sempre una base certa per il controllo e la salvaguardia della vita sotto vari aspetti.
Marco Sartore