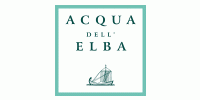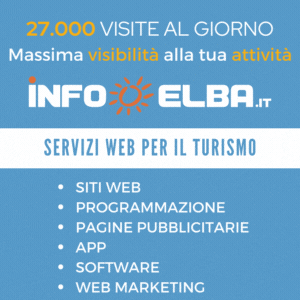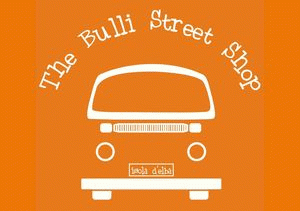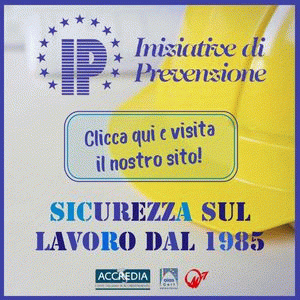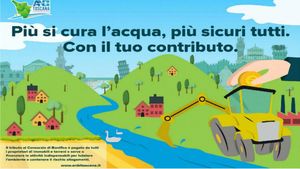Chi, all'Isola d'Elba, stanco delle spiagge affollate, della calca e degli ombrelloni, s'avventuri a cercare anche in pieno agosto qualche angolo più tranquillo, se non proprio vuoto, deve avere buone gambe e una buona riserva di fiato.
Bisogna lasciare la macchina o la moto, e scendere giù per dei sentieri sovente parecchio ripidi; è faticosa la discesa ed ancor più la salita, specie quando il sole è a picco. Si cammina e si suda, si suda e si cammina; ma, una volta arrivati, si capisce che ne è valsa davvero la pena. Così quando si scende a due piccole spiagge che non si vedono dalla provinciale panoramica verso Pomonte e Chiessi, dopo Fetovaia. Non si vedono e non sono segnalate da nessun cartello, anche per i loro nomi decisamente macabri, e che a qualcuno devono mettere pure un po' di paura: Le Tombe e Mortigliano.
Una accanto all'altra, separate solo da uno spuntone di roccia; una volta, alle Tombe, sono riuscito a starmene completamente da solo un dodici d'agosto, mentre Cavoli e Fetovaia sembravano “irriminite”, per dirla con un impareggiabile neologismo dovuto a mio fratello maggiore. Ma è successo molti anni fa, quando ancora non molti avevano un natante. Molti anni fa; e questa è una storia ancora più lontana.
Mortigliano e Le Tombe. Che razza di nomi, probabilmente derivati da qualche antica sciagura di mare; almeno quello delle Tombe sembra risalire ai tempi della scorreria saracena di Khayr al-Din (più noto come Ariadeno Barbarossa, figlio di un albanese musulmano e di una donna greca, nato a Mitilene nel 1478), nel 1543, quando tutti gli abitanti di Pianosa vennero uccisi o deportati, ed i cadaveri approdavano alle coste della vicina Elba che poi sarebbe stata ugualmente assaltata e saccheggiata; e provate ad immaginarvi quei posti ancora poc'oltre settant'anni fa. Perché questa, pur passata tra le maglie filtranti di qualche vecchia che ancora la raccontava quando avevo cinque o sei anni, è una storia vera, e con una data precisa: il 13 dicembre 1929. La notte di Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.
La strada che va da Marina di Campo a Marciana, passando per Fetovaia, Pomonte e Chiessi, è stata costruita a strapiombo sul mare, a forza di dinamite, dal 1960 al 1964. Prima non c'era che un sentiero, da farsi coi muli; oppure c'era il mare. Esistono, su dei bei calendari che si vendono nei chioschi dell'Elba ogni anno, delle foto dove si vedono dei contadini che vanno al mercato a vendere la loro roba, da quei posti, con l'asino infagottato fino all'inverosimile; ne tornavano con pochi soldi e con le provviste che dovevano bastare per chissà quanto tempo. Nonostante in una di quelle vecchie foto (forse degli anni ‘50, forse anteriore) si veda un uomo a dorso di mulo, mentre una donna, probabilmente la moglie, lo segue a piedi, le donne si muovevano raramente da quei paesi. Ancora negli anni settanta, quando la strada c'era già, mi ricordo d'aver conosciuto delle vecchie che non s'erano mai mosse dal paese; vi erano nate, e vi sarebbero morte. A Chiessi, una delle “attrattive” del luogo erano due vecchissime sorelle, entrambe vagamente simili alla strega Nocciola, la cui missione, da sempre, era quella di difendere la fontana dai foresti che venivano a prendere l'acqua coi canistri perché era acqua buona che scendeva dal monte; e la difendevano con le unghie e con i denti. A parolacce e graffi. Qualche volta c'era scappata persino una sassata o una seggiolata: a quelle due vecchie bisognava starci attenti se non si voleva tornare segnati. Si ricordavano, probabilmente, di quando a Chiessi non c'era che quella fontana, che doveva bastare per tutti quanti. Rubare l'acqua, era come rubare la vita; e qui non siamo negli anni ‘70 del XX secolo, ma direttamente nel Medioevo.
Proprio a Chiessi, nell'anno 1929, cioè quasi cent’anni fa, viveva un uomo il cui nome sembra essere stato Gaudenzio, o Godenzo (anche altrove, ad esempio nel Mugello, San Godenzo vuol dire San Gaudenzio). Non era nativo dell'Elba; veniva dalla Garfagnana, una delle terre toscane più povere e terribili, miniera inesauribile di storie e canti ancor più cupi e terrificanti, ed era un esperto muratore. Qui comincia la nostra storia, e quella dei suoi figli.
Perché quel Gaudenzio, o Godenzo, fosse arrivato dalla Garfagnana all'Elba, è presto detto: essendo un muratore, lo avevano chiamato per costruire. Un faro, per la precisione: quello di Punta Polveraia, che è l'estremità della cala di Patresi, subito dopo Chiessi.
Sono acque pericolose, piene di scogli affioranti, e battute da venti che cambiano all'improvviso, e violentemente. Sono acque che, di morti, ne hanno fatti tanti; e li fanno ancora, come un turista francese che mi capitò d'andare a tirar fuori dall'acqua, gonfio e annegato, nell'estate del 1981, dando una mano su una vecchia ambulanza ricavata da una Fiat 125, sulla quale a volte prestavo servizio volontario. E mi ci toccò fare, assieme a lui, anche il viaggio al vecchio cimitero di Marina di Campo, in piena notte. L'autista guidava, l'altro volontario stava seduto accanto a lui ed io, visto che ero il più giovane, dietro, seduto accanto al cadavere sulla lettiga, coperto da un lenzuolo. Ad ogni curva, la salma si rigirava, e dovevo tenerla per evitare che mi cascasse addosso.
Un faro ci voleva, per forza. Piccolo piccolo, ma che facesse un po' di luce su quel mare che, alle volte, s’incarogniva. Ed era andata a finire che Gaudenzio, finito di costruire il faro, era rimasto all'Elba. Per il motivo più antico e naturale di questo mondo: aveva conosciuto una ragazza di Chiessi, l'aveva corteggiata come si faceva a quei tempi, ci si era fidanzato e l'aveva sposata. Miseria per miseria, aveva scelto quella dell'isola; ché, tanto, ci si faceva la fame come in Garfagnana, ma perlomeno c'erano un po' di mare e un po' di vigne.
Questo doveva succedere verso il 1890. Ma Gaudenzio non era tagliato per fare il marinaio o il pescatore; era un montanaro, e un montanaro era restato. Poco dopo sposato, con mille sacrifici aveva acquistato un mulino, che era l'unico della zona; ed era arrivato un po' di benessere, per quanto benessere si potesse avere laggiù, a quell'epoca, per lui, per la moglie e per i figli che erano venuti al mondo uno dietro l'altro. Nel 1929 erano arrivati a nove; quattro maschi e cinque femmine.
I due maggiori tra i maschi si chiamano uno Lorenzo e l'altro Rinaldo; trent'anni il primo e ventiquattro il secondo. Essendo venuti al mondo lì, erano diventati pescatori anche se, come è ovvio, sapevano fare di tutto: macinare il grano e fare il pane, coltivare la vigna, costruire i muri a secco, spaccare la legna, fare ogni tipo di riparazioni. Il 13 dicembre 1929 era un giorno speciale per tutta la famiglia: Gaudenzio, che non s'era certo scordato di come si faceva il muratore, aveva costruito infatti un nuovo magazzino per la farina. Era un giorno di festa anche per il paese: con il magazzino, infatti, si sarebbero potute accumulare le provviste di farina senza dovere per forza andarla a comprare a Campo o a Marciana Marina, con tutti i disagi del viaggio, specialmente d'inverno. Per l'apertura del magazzino venne scelto proprio il giorno di Santa Lucia; il parroco, don Leto, un còrso arrivato lì non si sa quant'anni prima, tanto tempo da aver dimenticato il dialetto di Propriano dov'era nato, dopo aver detto messa alla Santa, avrebbe dovuto battezzare il magazzino. Proprio così si faceva: il prete arrivava con l'ostensorio, benediceva la costruzione e l'aspergeva con l'acqua santa. Un battesimo vero e proprio, come si faceva del resto con le barche nuove prima di metterle in mare.
Il giorno prima sembrava quasi tornata la primavera. Un caldo fuori stagione, una giornata bellissima da stare in camicia, un mare stranamente liscio come l'olio. Tutto quel che ci voleva per pigliare il gozzo e mettersi a pescare. Un po' di pesce fa sempre comodo. La vita è sempre dura, grama, ed ogni piccola cosa va conquistata a fatica, giorno dopo giorno. E poi, magari, si potrà servire un po' di pesce al rinfresco dopo il battesimo del magazzino. Non è una festa di famiglia: è festa per tutto il paese, per tutti quanti.
I due fratelli, dopo cena, sortono in fretta di casa con pochi arnesi per la pesca. Sono due marcantoni; il primo è già sposato e ha due figli piccoli, il secondo è appena tornato dal servizio militare, che durava tre anni. Sortono di casa probabilmente meravigliandosi del caldo che fa, in quel dodici dicembre; alle dieci la sera, quando si va di solito in mare per la pesca, in quella stagione si dovrebbe bubbolare dal freddo e dall'umido, e coprirsi perbene coi maglioni e con le cerate. E, invece, sembra di stare a maggio.
A questo punto della storia, chi legge deve immaginarsi un piccolo spaccato di cultura orale, cioè di qualcosa che non esiste più. Finita. Morta. Kaputt. Un gruppo di donne anziane che la racconta, con un vecchio che gioca il ruolo del guastafeste: è lui che sa tutto, che corregge, che dà il rimbecco alla narratrice principale (le altre aggiungono solo dei particolari), che s'arrabbia se si divaga troppo. Però non è questione che racconti lui, direttamente: le storie le devono raccontare le donne, specialmente se ci son dei bambini presenti. Ecco, uno di quei bambini presenti ero io. Invariabilmente, s’arrivava al punto della storia dove s’avvicinava la catastrofe, perché è raro che una di queste storie vada a finire bene; e la catastrofe, cioè la “distruzione” (καταστροφή), ha bisogno di segnali che ne preannuncino il sopravvenire.
Dunque, i due fratelli Lorenzo e Rinaldo mettono in mare la barca e s'avviano al largo con rapidi colpi di remo; una delle narratrici parla di strani lampi verso la Corsica, mentre un’altra racconta di strani rumori che arrivano dal buio e addirittura di sinistri ululati come se ci fosse un lupo in mezzo al mare. Il vecchio guastafeste, da buon “Gigi-sa-tutto”, non è mai d’accordo su queste scemenze, ma quando una delle donne nomina la Madonna, deve chinare il capo e assentire. Sulla presenza della Madonna non si può, ovviamente, discutere. Intanto, i bambini ascoltano zitti e atterriti, e guai a fiatare. Era cambiato il vento, all'improvviso. Solo questo. Come succede spesso in mare aperto, e non solo in pieno inverno.
Aveva messo ponente, e una ponentata, da quelle parti, è capace di pigliare un peschereccio bello pesante e di sfracellarlo sugli scogli; figurarsi un gozzo a remi. Da lontano si sente probabilmente come un sibilo, ma i due fratelli non ci fanno caso; remano come forsennati e, arrivati verso Campolofeno, dove l'acqua è profonda cento metri, cominciano a pescare. Ed è una cosa mai vista. Pesci su pesci. E su pesci ancora, di tutti i tipi. Sembra che il mare voglia partecipare alla festa per il magazzino, dando da mangiare a tutta Chiessi, a Pomonte, a Patresi e al Colle d'Orano.
Il vecchio interrompe ancora la narratrice: "Ma te lo scordi sempre di di' der detto di Santa Lucia!"; perché, dovete sapere, che all'Elba non si deve mai andare a pescare, o comunque mettersi in mare, in quella notte. Santa Lucia è la santa cieca, che toglie la luce del giorno per dar quella dell'eterna beatitudine; e, nella sua notte, il mare da un momento all'altro può farsi inquieto ed agitarsi fino a diventare un nemico invincibile.
Se n'accorge Palmiro, un vecchio di Chiessi, che accortosi del repentino cambiamento del vento ha preso la sua barca e s'è gettato verso i due sciagurati fratelli che, nel frattempo, sono abbagliati dalla pesca abbondante e non si curano delle onde che si vanno accrescendo. Il vecchio Palmiro arriva vicino, e urla: "Venite via, ché c'è maraccio! Tornate a casa alla svérta ! Fa buràsca!"
Lorenzo e Rinaldo si guardano un po' incerti. Si sono resi conto che il mare si sta alzando, ma non vorrebbero lasciare tanta grazia di Dio. Ma è troppo tardi. Palmiro ce la fa a allontanarsi appena in tempo; il mare è diventato livido, gonfio e prende minaccioso ad incalzare. Le onde sono sempre più forti e scuotono con violenza il piccolo gozzo che sembra un fuscello sbattuto qua e là, senza più governo. I due fratelli sono sgomenti, ma non perdono la speranza: remano con rabbia, arrivano già a metà percorso e presto saranno a casa. Ma non hanno fatto i conti con le secche; e le secche sono proprio davanti a Mortigliano. Fra Mortigliano e le Tombe. E quelle secche s’avviano infatti a diventare le loro tombe.
La povera barca viene rovesciata dalle ondate paurose che si infrangono sulle secche; ma ancora Lorenzo e Rinaldo, scaraventati in mare, non demordono e lottano come possono. Cercano di raggiungere la spiaggia a nuoto, non è lontana; con un mare appena un po' meno tremendo ce l'avrebbero fatta in cinque minuti. Ma non c'è niente da fare. Un'ondata afferra prima uno, e poi l'altro. Sono sbattuti con forza, chissà quante volte, contro gli scogli appuntiti e taglienti come rasoi appena affilati.
Sconciati da una notte di tempesta e irriconoscibili persino ai fratelli, alle sorelle e al padre, così li trovano la mattina dopo. E uno degli altri due fratelli maschi, Francesco, che se ne accorge e va a avvertire il padre e il parroco, che quel giorno avrebbe dovuto benedire il magazzino appena finito di costruire. Il giorno di festa si volge in giorno di dolore e di lutto. La madre, Beppina, si chiude in casa nel suo dolore che mi piace d'immaginare composto quando duro. In realtà, non ne so niente. Qui sono io, la vecchia che racconta. Sono io il narratore, e ormai vado a ruota libera.
E vedo, anzi voglio vedere, una processione che attraversa una ripida e aspra montagna che ben conosco, passando per la via dell'Omo che, a un certo punto, si congiunge con quella della Madonna del Monte. Hanno portato due lettighe fatte d'assi di legno e li hanno coperti con dei lenzuoli per riportarli a casa. Non suona nessuna campana, perché la campana a morto deve rintoccare al momento del funerale. La giovane moglie di Lorenzo è chiusa in casa coi bambini, ai quali è stata nascosta la verità; il mare è tornato beffardamente calmo. Un olio. Fa di nuovo quasi caldo.
Così andava, in quei poveri posti capaci solo di generare povere storie. Ora è cambiato tutto; a Chiessi, le antiche case dei pescatori sono state trasformate in bellissime casette per le vacanze. E' un posto incantevole; ma a buttarsi in quel mare bisogna stare sempre attenti.
Esiste ancora il magazzino costruito da Gaudenzio, quel magazzino che non fu mai battezzato in quel tragico e lontanissimo giorno. E' vicino al ponte di legno che attraversa un fosso che scende giù dal monte Giove.
E esiste ancora una lapide, a Marciana, che Gaudenzio pagò e fece scolpire anni dopo per ricordare quella notte di Santa Lucia. Ma è sbiadita dal tempo, oramai. Chissà per quanto ancora vi si leggeranno i nomi, e quella vicenda raccontata nel pomposo stile dettato, chissà, da un maestro di scuola o da un prete. Arriverà il giorno in cui, di questa storia, non si ricorderà più nessuno; quelli che l'hanno vista sono morti, quelli cui l'hanno raccontata sono morti e anche quelli cui è arrivata per le strade del tempo non stanno troppo bene. E così ecco riciclata anche la famosa battuta attribuita a Woody Allen. Si scrive, del resto, non per la vanità, per la fama, la gloria e altre cretinate del genere; si scrive per un tentativo, ancorché ingenuo, ancorché del tutto inutile, di fermare il tempo. Soprattutto il proprio.
Riccardo Venturi