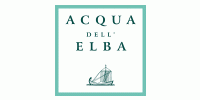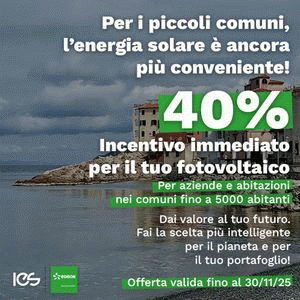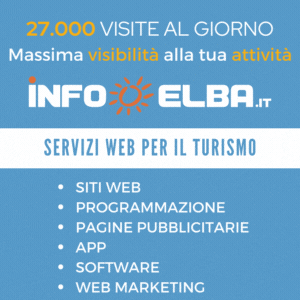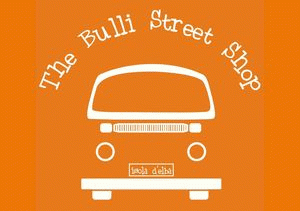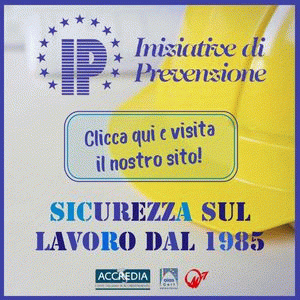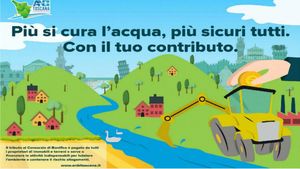Ultimamente è tornata in auge la notizia di una possibile visita all'Elba di Leonardo da Vinci, di cui credo di essere stato il primo a parlarne, nel cinquecentenario della morte del genio toscano. Preferisco lasciar perdere la polemica tutta marinese (e tutta politica più che culturale). Decisamente più interessante il contributo dell'articolo a firma LF, dove si cita un mio articolo di sei anni fa (di cui ringrazio l'autore per la citazione).
https://www.elbareport.it/arte-cultura/item/72712-leonardo-sulla-spiaggia
Ritorno volentieri sull'argomento, per aggiungere qualche particolare. Innanzitutto riporto due immagini. La prima è il verso della pagina 31 del Codice Leicester, dove viene evidenziato il testo che afferisce all'Elba, citato da me (nel 2019) e recentemente da LF. Ma il particolare più interessante è nella seconda immagine. Il particolare della frase “come nei liti dell'Elba si dimostra”. La scrittura di Leonardo (che, ricordiamo, nei suoi manoscritti scriveva alla mancina, quale lui era, ovvero da destra a sinistra) è minuta, di difficile decifrazione, ma straordinariamente lineare, nonostante cancellature e aggiunte. Eppure si nota che la frase in questione non è inserita nel normale fraseggio, ma in un'interlinea, come se fosse stata aggiunta successivamente, in una revisione del testo.
La ragione di questa aggiunta, quasi una nota al testo primario, probabilmente rimarrà sempre oscura. Forse che a Leonardo fosse venuto in mente in un secondo tempo che la spiegazione della levigatura dei ciottoli l'aveva verificata all'Elba? In ogni caso il fatto che includesse la frase al discorso era evidentemente per lui essenziale, come prova empirica di quanto stava affermando.
Tutto questo però non risponde alla domanda chiave. Leonardo è davvero stato all'Elba? In questi anni ho chiesto a conoscitori del genio di Vinci se è possibile che Leonardo potesse basare i suoi studi su conoscenze indirette e non condotte personalmente sul posto di cui parla. Mi hanno risposto che a priori non si può escludere che certe impressioni, seppure in casi limitatissimi, potessero giungergli di seconda mano o su opere di autori precedenti. Nello stesso Codice Leicester, per esempio, Leonardo cita luoghi, come il Caspio e il Danubio, che l'autore non può aver visitato, e che quindi facesse riferimento ad altre fonti.
Ma sappiamo anche che il genio toscano aveva un approccio scientifico in anticipo sui tempi, che lo portava a verificare sempre le sue osservazioni, nonché a comprovarle con esempi specificamente studiati. Poco sotto la citazione dell'Elba infatti leggiamo: “E di questo [la formazione di rena in tufo] si vede l'esemplo in Adda, all'uscire de' monti di Como, e in Tesino, Adice, Oglio, e Adriano dell'Alpe de' Tedeschi; e 'l simile d'Arno, del monte Albano, intorno a Monte Lupo e Capraia”. Per provare la sua tesi dunque in questo caso Leonardo cita fiumi e luoghi lombardi che sappiamo con certezza aver ben conosciuto nel suo periodo alla corte milanese di Ludovico il Moro (1482-99); per non parlare dei suoi luoghi natii e dell'Arno, per il quale studiò diversi progetti, ben documentati nei suoi codici, per deviarne il corso.
Insomma, probabilmente non avremo mai la certezza se Leonardo sia stato all'Elba. Quella piccola interlinea è solo un indizio. Ma, come già facevo osservare nel mio articolo, la certezza della sua presenza a Piombino, il riferimento così sibillino alla nostra isola (perché portare l'esempio elbano, se non era importante per le sue osservazioni?), una mentalità scientifica che lo portava pressoché sempre all'osservazione diretta e non mediata da fonti di seconda mano, fa di quell'indizio un elemento da prendere in seria considerazione.
Andrea Galassi
p.s. La pagina del Codice Leicester si può leggere più chiaramente delle mie foto, in forma digitalizzata, al sito leonardodigitale.com/sfoglia/codice-leicester/0031-v