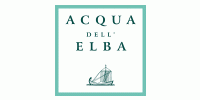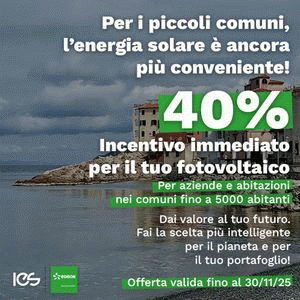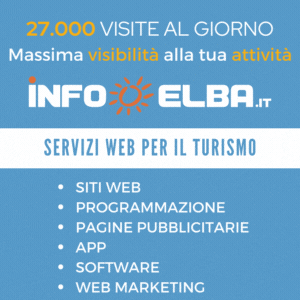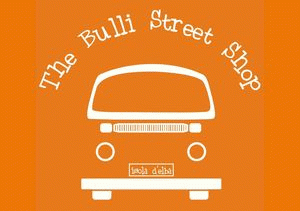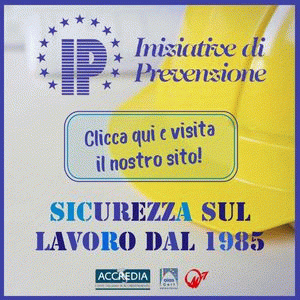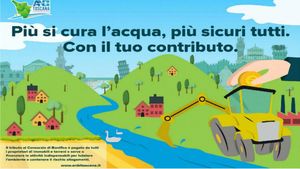Il sole dell’alba tinge di rosa il cielo del Cavo. Dal continente una lama dorata arriva alla spiaggia della Cala dell’ Alga. Siamo all’estremo settentrione della Terra del ferro. Iniziamo il nostro cammino.
Si prende lo stradello costiero che da Cala dell’ Alga porta a Capo Vita, per poi percorrere il pianoro che risale ai 112 m. (slm) del Mausoleo Tonietti, in prossimità della cisterna che serviva la villa romana di Capo Castello.
Il Mausoleo venne edificato agli inizi del Novecento dall’architetto Adolfo Coppedè , per accogliere le spoglie di Giuseppe Tonietti, concessionario delle miniere elbane. Ma venne a mancare l’autorizzazione cimiteriale e il monumento fu abbandonato al degrado.
Siamo sul fianco del Monte Lentisco, coperto da un fitto bosco di lecci, di pini e di essenze tipiche della macchia mediterranea alta.
Un campionario di colori e profumi: dai lentischi, con eccezionali esemplari a portamento arboreo che danno il nome al luogo, al mirto (la mortella degli elbani), al ginepro e al corbezzolo, alle ginestre e all’erica arborea. Il pianoro di Capo Vita è una possibile spianata di erosione marina del Pliocene inferiore (5- 3,5 Ma), e lì incontriamo le formazioni sedimentarie della Unità ofiolitica nella facies di Monte Strega. Un pezzetto del fondo di un oceano- l’Oceano Ligure Piemontese-, che per circa settanta milioni di anni, fra il Giurassico medio e il Cretaceo medio (170-100 Ma) divideva la Paleoafrica dalla Paleoeuropa.
Si tratta di affioramenti di Argille a Palombini (pb) e di Calcari a Calpionelle (Cc). Le Argille a Palombini sono il nome antico di una formazione sedimentaria costituita da livelli di argilliti grigio scure alternati a calcari grigio chiaro-il colore dei colombi- più o meno silicizzati e gradati. E’ una roccia formatasi dalla litificazione di materiali originariamente sedimentati nel pendio di una scarpata continentale e successivamente franati e risedimentati nella prospicente piana abissale, durante periodi di tempo ad elevata attività sismica. Questo, per quanto riguarda le Argille a Palombini, avveniva nell’Oceano Ligure, durante il Cretacico medio (Hauteriviano-Cenomaniano) fra 136- 93 Ma. In generale, queste formazioni prendono il nome di “torbiditi” o “flysch”, e sono presenti in varie tipologie nelle sequenze sedimentarie sia liguri che toscane.
I Calcari a Calpionelle consistono di una successione monotona di strati di calcari a granulometria fine e compatta di colore grigio chiaro o bianco, con tipica frattura concoide. Stratificamente sottostanno alle Argille a Palombini e come ben evidente lungo il sentiero, il passaggio è graduale con intercalazioni di livelli argillitici in prossimità del contatto. Il contenuto in fossili, in particolare di calpionellidi (protozoi planctonici estinti a scheletro calcareo) che danno nome alla formazione, indica una età del Cretacico inferiore (Berriasiano terminale-Hauteriviano p.p.; 140- 136 Ma). L‘ambiente di deposizione è pelagico sopra il limite di compensazione dei carbonati ( CCD= Calcite Compensation Depth): la profondità sotto la quale la calcite viene disciolta dall’acqua marina e la sedimentazione,
a meno di particolari ambienti, diviene essenzialmente silicea.
Dal Mausoleo Tonietti il sentiero piega ad occidente girando attorno al Monte Lentisco (154 m.), e sovrasta Cala Cancherelli e Cala Mandriola.
In queste calette affiorano depositi dunali antichi. Si tratta di eolianiti che ritroviamo anche in altri luoghi dell’Isola esposti ai venti di ponente, come Madonna delle Grazie di Capoliveri, Viticcio e Monte Stella.
La loro formazione, datata al radiocarbonio è compresa fra 48.000 e 21.000 anni fa. Siamo nell’ultimo periodo glaciale, più o meno quando i primi sapiens giungevano nelle contrade elbane incontrando, forse, gli ultimi neanderthal , che ormai da qualche decina di migliaia di anni frequentavano il territorio. Al tempo la calotta artica arrivava fino all’ Europa centrale; i ghiacciai alpini si sviluppavano fino alla Padania; piccoli ghiacciai erano nelle Apuane e forse nevi perenni riempivano il catino de La Galera nel massiccio del Monte Capanne. Il ghiaccio spaccava le “cipollature” del granito; il vento, la sabbia, il sale erodevano e scolpivano le rocce. Nel Capanne si creavano: macei, tor, lisce, coti e “Mostri di pietra”.
Il livello marino scendeva fino a 120 m. sotto l’attuale, e l’Elba unita a Pianosa, all’ Affrichella ed al continente era una penisola che si protendeva verso la Corsica e Capraia. Il profondo Bacino della Corsica segnava la cicatrice fra il Mondo europeo- alpino della Corsica e Sardegna, e il Mondo africano della Toscana. L’ursus spelaeus, l’orso delle caverne, frequentava la Grotta del Reale a Porto Azzurro. Nei boschi di querce, carpini, olmi, pini, betulle, faggi; nelle steppaie e negli acquitrini della grande penisola elbana, vivevano oltre agli orsi: cinghiali, cervi, caprioli, leoni delle caverne, rinoceronti, ippopotami, cavalli e lepri.
Difficile oggi immaginare quel Mondo guardando il grande mare di Pelagos che si estende davanti a noi, ma questo sembrano dirci le rocce presenti nei suoi fondali esplorate, “un tempo ormai passato” con alcune trivellazioni alla ricerca di idrocarburi, nonché i fossili ritrovati nella grotta dell’orso di Porto Azzurro.
Il cammino lungo la GTE- magari dopo una piacevole sosta al Ristoro Amandolo-, prosegue verso il Serrone (155 m.) e per circa 300 metri percorre un affioramento di argilloscisti policromi. I colori, che virano dal grigio-verdi, al rosso vinaccia e all’avana, esaltano il fitto intreccio di venette quarzose e gli straterelli di calcescisti e diaspri che talora emergono dalla formazione. Le caratteristiche sedimentologiche e paleontologiche sono quelle di una roccia debolmente metamorfica originata dai sedimenti deposti in un ambiente pelagico del Cretaceo superiore (100- 65 Ma). Una caratteristica saliente è che presentano notevoli similitudini con gli” scisti lucenti “metamorfici del dito della Corsica e di Gorgona. Nella Geocarta del 2015 queste litologie - denominate Formazione di Cavo ( FCV), e assegnate alla Unità di Grassera-, sono riportate in una lunga striscia di territorio che passa dalla Chiesetta di San Quirico, là dove sorgeva l’antico villaggio minerario di Grassera, ed arriva fino al Piano fra Rio Elba e la Piaggia.
La GTE scende quindi a Casa Muti (109 m.), eretta su un affioramento di oficalciti (OFI), alla testa del vallone che porta alla Cala del Pisciatoio. Petrograficamente sono delle serpentiniti, estremamente alterate, tagliate da sciami di fratture riempite di calcite spatica. Sono il “marmo mischio” che pavimenta la Galleria Demidoff alla Villa napoleonica di San Martino; quello con il quale sono state fatte l’acquasantiera dell’Eremo di Santa Caterina e le colonne dell’altare della Chiesa-fortezza dei Santi Giacomo e Quirico che, come ricorda la lapide murata dietro l’altare, fu rifugio delle genti Rio e di Grassera, durante le scorrerie delle bande del Barbarossa e di Dragut.
Da Casa Muti lasciamo per una piccola deviazione la GTE, e prendiamo il sentiero che scende sopra le falesie di Cala Mendolina. Qui si trovano i suggestivi scavi dei Grottini: una delle piccole miniere di ossidi di manganese (in particolare pirolusite) aperte nella prima metà del secolo passato nel territorio di Rio. Il minerale estratto veniva gettato direttamente nella spiaggetta della sottostante Cala e da qui, raccolto e trasportato con i barconi allo stabilimento siderurgico di Portoferraio.
Tornati a Casa Muti la GTE passa sopra un accumulo di clasti spigolosi ed eterogenei di un deposito di versante, associabile a fenomeni di alterazione clioclastica, quinti si entra in una vasta area di affioramento dei Calcari a Calpionelle per giungere al semaforo del Monte Grosso (346 m). E’ questo un punto di sorveglianza e segnalazione militare, dismesso dopo la Seconda Guerra mondiale, nonché nodo della rete di telegrafi ottici allestita da Napoleone durante il suo Principato elbano.
Lasciata la cima di Monte Grosso e il grandioso panorama che lo circonda, il sentiero sempre sui Calcari a Calpionella, scende a Casa Colli (140 m) per poi risalire lungo le pendici orientali di Monte Peritondo (287 m). Poche centinaia di metri prima di Casa Nardelli (221 m), si incrocia una strisciata di territorio dove affiorano altre formazioni della Unità Ofiolitica, rappresentate da: rocce diasprine e calcareo selcifere (di e FNI), serpentiniti (∑) e basalti (∆).
Le serpentiniti (o ofioliti p.d. ), sono delle peridotiti parzialmente o completamente alterate per interazione con soluzioni marine calde che, in modo particolare, hanno trasformato l’olivina in serpentino. Per quanto riguarda i basalti della Unità ofiolitica, si tratta di accumuli lavici sottomarini con una tipica struttura a cuscini (pillow lava) inclusi in una massa di fondo vetrosa e variamente brecciata. I basalti soggiacciono a livelli di diaspri. Questi sono costituiti dall’accumulo in ambiente pelagico, sotto il limite di compensazione dei carbonati (CCD) di resti di radiolari, protozoi planctonici a scheletro silice. I diaspri (o radiolariti) si presentano sottilmente stratificati, di colore rosso o più raramente verdastro, intercalati con modeste presenze argillitiche. La loro età spazia dal Giurassico medio, alla base del Cretaceo (Calloviano inf.- Berriasiano; 165- 140 Ma) e passano gradualmente alla sovrastante formazione dei Calcari a Calpionelle.
All’Elba peraltro, spessi strati di calcari selciferi grigio chiari intercalati ad abbondanti argilliti verdastre e marne rossastre più o meno silicizzate si interpongono talora fra i diaspri e i Calcari a Calpionelle. Queste rocce nella Geocarta del 2015 sono state distinte dalla Formazione dei diaspri, istituendo la Formazione di Nisportino (FNI), il cui contenuto in nannofossili e calpionellidi indica un’età della base del Cretaceo (Berriasiano; 145-140 Ma) e un ambiente di deposizione pelagico oceanico vicino alla CCD.
La strisciata ofiolitica prosegue sopra la Cala di Nisportino fino in prossimità dell’ Aia di Cacio, là dove la GTE incrocia la strada che da Rio conduce a Bagnaia. Qui tornano gli affioramenti di Calcari a Calpionelle sui quali nel passato erano state aperte alcune piccole cave per pietra da calce, che sarebbe opportuno, per usare un eufemismo, bonificare ed evitare che siano utilizzate come discarica dai pochi “piccoli criminali” che a disprezzo dell’ecologia e della cultura di tanti, lasciano i loro rifiuti dove capita. L’ ESA (Elbana Servizi Ambientali) sviluppa un efficiente e lodevole servizio di raccolta differenziata porta a porta, e di prelievo di rifiuti ingombranti. Tutto ciò rappresenta un impagabile valore aggiunto per l’ ambiente e l’economia elbana e non possono essere più tollerate le inciviltà di pochi, elbani o foresti che siano.
Ed ora dall’ Aia di Cacio lasciamo la GTE e prendiamo il sentiero che conduce alla cima del Monte Serra (422 m.). E’ un sentiero molto bello che taglia una lussureggiante macchia di ginepro, cisto, erica, ginestre e giunge alla “cavina del marmo mischio”, aperta in una massa di oficalciti che sovrasta l’Eremo di Santa Caterina. Poco oltre, nascosto nella macchia si scopre un pavimento di serpentinite , in cui sono scavati tre piccoli pozzetti: i crogiuoli del “fabbrichile” dei fabbri pisani che nel Basso Medioevo, frequentavano quel luogo per forgiare, chiodi, ferri per l’asino, falci,…come attestano i reperti conservati nel Museo archeologico di Rio. Il fabbrichile di Monte Serra ci ricorda Riccardo Francovich, che lo scoprì, e i momenti in cui guardavamo il panorama grandioso che si apre da quel luogo: la Torre del Giove, la Montagna del ferro, la Chiusa dei Taddei Castelli, Santa Caterina, Rio Elba, e a sud il vallone di Ortano e il profilo di Calamita. La Torre del Giove domina le zone minerarie che dai cantieri di Rio Albano arrivano ai cantieri di Rio Marina. La Torre o meglio la splendida Fortezza, venne edificata sulla spianata della montagnola piramidale coperta di lecci, a vista del Volterraio, di Marciana e di Capoliveri, dagli Appiani nel 1459 per proteggere i loro possedimenti e le miniere elbane. Purtroppo, come accennato, non protesse il borgo minerario di Grassera. Comunque la Torre, più o meno, continuò ad espletare le sue funzioni difensive del territorio, fino a quel giorno del 1708, quando gli Spagnoli che occupavano Porto Longone, ma di fatto presidiavano tutta l’ Isola, decisero di smantellarlo per rappresaglia per il contegno “non troppo collaborazionista” tenuto dagli elbani durante gli eterni conflitti fra Francia e Spagna. Oggi della Torre restano imponenti e suggestivi ruderi carichi di storia e di leggende, immersi nelle tante ombre tagliate da sferzanti lame di luce di una fitta e
incantata lecceta.
La Torre del Giove sovrasta la grande vallata che dal Monte Capannello scende a Rio Elba e, lungo la Valle dei Mulini, conduce alla Piaggia e alla Montagna del ferro. A metà strada, la Piana di San Giuseppe, dove due montagnole di calcare coperte di lecci si elevano dai campi. Nelle montagnole si aprono numerose cavità carsiche, in una delle quali, 4000 anni fa, trovarono rifugio e sepoltura genti della cultura eneolitica di Rinaldone: probabilmente i primi cercatori di metalli elbani i cui resti e i corredi che li accompagnano sono esposti nel Museo Archeologico di Rio Elba. Erano, più o meno, i tempi durante i quali a Creta splendeva la civiltà minoica e la piramide di Cheope da cinquecento anni dominava il paesaggio di Giza.
Ma torniamo ora all’Aia di Cacio, non senza avere ricordato il Campo rapaci del Monte Serra organizzato dal PNAT e dal Centro Ornitologico toscano. Un punto di monitoraggio di falchi, sparvieri, cicogne nere e
numerose altre specie, nel loro viaggio migratorio fra Europa e Africa, attraverso i ponti della Corsica e della Sardegna, all’inizio e alla fine dell’Un pezzetto del fondale estate.
Beppe Tanelli
(Figura: La GTE Cavo- Aia di Cacio tracciata sulla Geocarta del 1967 con indicate a mano le sigle delle formazioni introdotte nella Geocarta del 2015)