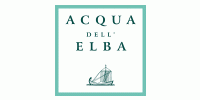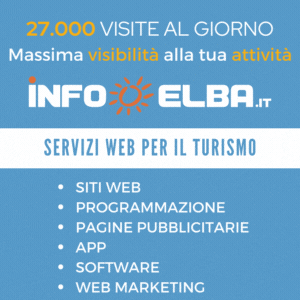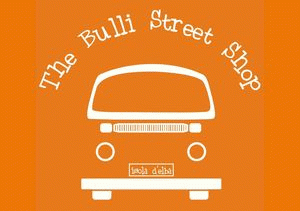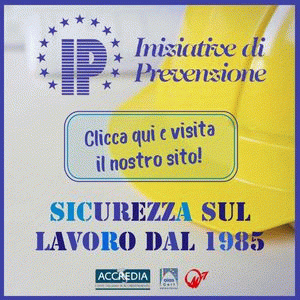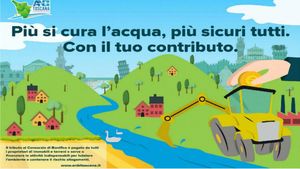Nel 1920 l’esposizione finanziaria mette a rischio la sopravvivenza della società e nel 1924 viene effettuato un primo salvataggio per mettere al sicuro gli impianti di Piombino e di Bagnoli (quest’ultimo entrato in produzione nel 1910).
Nel 1931, anche a seguito della crisi del ’29, sovrapproduzione e difficoltà finanziarie mettono di nuovo in crisi il settore dell’acciaio che viene salvato e nazionalizzato nella nascente IRI. All’interno di tale Ente, nel 1937 nasce Finsider e viene potenziato Bagnoli che, nello stesso anno, occupa 4000 operai e produce 317000 t di ghisa e 177000 t di acciaio. In tale periodo in parallelo operano le acciaierie di Terni , di Piombino e la Siac (società italiana acciaierie di Cornigliano) che raggruppa le attività di Ansaldo (Genova). Da notare che nel 1939 nasce la O.T.O. (società Odero, Terni, Orlando) che alla Spezia gestirà le industrie meccanico-navali dell’alto Tirreno.
Durante il secondo conflitto mondiale le attività siderurgiche subiscono gravi danni: L’altoforno di Portoferraio viene distrutto da ripetuti bombardamenti come l’impianto di Piombino (10/04/’44). Bagnoli viene distrutto dai tedeschi dopo l’armistizio o durante la ritirata.
Nel caso di Bagnoli le maestranze subito si adoperano per riattivare l’impianto senza il favore degli Alleati.
Nel dopoguerra De Gasperi con Sinigaglia rilancia lo stabilimento di Bagnoli come centro produttivo principale e viene aggiunto, dalla contigua Cementir a fine anni ‘50, un altro altoforno.
Nel 1964 lo stabilimento di Bagnoli, da Ilva, entra nel gruppo siderurgico che viene denominato Italsider che tenta di assumere importanza mondiale con l’inaugurazione nel 1968, ad opera del Presidente Saragat, del quarto polo di Taranto. Si progetta anche un quinto polo siderurgico a Gioia Tauro, che, però, non nascerà mai; rimarrà, in tal luogo, il porto costruito ad hoc.
Nel ’69 la produzione dell’acciaio comincia a diminuire per concorrenza mondiale e per limiti imposti dalla comunità europea. Dal 1981 al 1984 tutto il comparto siderurgico viene ristrutturato e nasce la Nuova Italsider (Taranto, Bagnoli, Cornigliano, Novi Ligure) affiancata dalle Acciaierie di Piombino.
Nel 1985 viene decisa la chiusura dello stabilimento di Bagnoli perché in contrasto con la normativa urbanistica di Napoli. L’impianto, dopo opere di ambientalizzazione per 1200 miliardi, viene svenduto a cinesi ed indiani per 20 miliardi e dal ’96 al ’99 smantellato completamente con la demolizione dei capannoni e della centrale elettrica.
La produzione Italsider continua principalmente a Taranto ma la concorrenza mondiale mette in crisi lo stabilimento che opera in perdita. Lo Stato decide di privatizzare l’attività e nel 1995 vende l’Italsider alla famiglia Riva per 2400 miliardi che ritorna alla vecchia denominazione “Ilva”. Dal 1995 al 2012 l’aumento di produttività porta a problemi ambientali poiché l’acciaieria era stata costruita vicino al quartiere “Tamburi” di Taranto. Avvengono proteste e denunce per danni alla salute causati principalmente dalle polveri minerali, dal benzopirene emesso dalle cokerie e dalla diossina sprigionata dagli impianti di agglomerazione.
Nel 2012 viene riaperta la procedura AIA (autorizzazione integrata ambientale) per recepire anche le nuove direttive europee in merito (con entrata in vigore nel 2016). Viene firmato un protocollo di intesa per interventi di bonifica e riqualificazione impianti e, nel contempo, emanato un decreto che stanzia fondi per il risanamento e rilancio della città di Taranto. Ma la situazione era ormai degenerata ed i GIP della città sequestra l’area a caldo ed incolpa la gestione dello stabilimento di anteporre il profitto alla salute ed alla sicurezza. Dispone, altresì, l’arresto di Emilio Riva e dei responsabili dell’area a caldo (altiforni , cockerie ed impianti connessi). Successivamente verranno fatte opere per diminuire gli inquinanti.
Il 14 Aprile 2013 un referendum non valido (votanti <20%) boccia l’acciaieria a larga maggioranza.
Nel Giugno 2013 viene attivato il commissariamento dell’acciaieria con la nomina di Enrico Bondi e vice commissario Ronchi. Una relazione presentata da Bondi afferma che la mortalità nei quartieri limitrofi è in diminuzione e non causata dall’inquinamento industriale.
La vertenza giudiziaria porterà all’assoluzione dei Riva.
Con l’amministrazione straordinaria i creditori dell’indotto perderanno circa 120 milioni di euro.
Nel 2017 l’impianto viene rilevato dalla società franco-indiana Arcelor Mittal con una quota societaria di maggioranza del 68%, mentre il restante 32% viene mantenuto dallo Stato nella veste di Invitalia.
Dal 2018 ricominciano problemi ambientali con denunce e sequestri riguardanti sempre principalmente l’area a caldo: alti forni e cokerie. Lo Stato con apposito decreto attiva uno “scudo penale” per i dirigenti operanti nei settori incriminati , valido fino a compimento delle opere di ambientalizzazione. Ma successivamente tale scudo viene tolto e gli impianti diminuiscono molto l’attività arrivando a produrre meno di 3 milioni di tonnellate anno di acciaio a fronte di una potenzialità di quasi 10 milioni.
I debiti dell’azienda aumentano e si arriva all’ingiunzione del pagamento di 320 milioni di euro per il gas, pena la chiusura della fornitura. Inoltre l’indotto reclama crediti per 150 milioni di euro. Arcelor Mittal non vuole più versare capitali e si arriva alla situazione odierna con lo Stato che tramite Invitalia è disposto a versare 320 milioni di euro assumendo però il controllo dell’azienda al 68%.
La vertenza è aperta e lo Stato minaccia il ricorso all’amministrazione controllata straordinaria.
Non molto dissimili sono le vicende del polo siderurgico di Piombino, affiancato, in tale luogo, dalla Magona d’Italia e dalla Dalmine. Il centro siderurgico, dal 1965 al 1990 con varie vicissitudini cambia denominazione sociale (Deltasider, Nuova Deltasider, Ilva spa, Teksid) e si indirizza successivamente verso gli acciai speciali, mentre le maestranze si riducono dal massimo degli 8000 alle 4000 unità. Nel 1992, dopo la decisione di chiudere Bagnoli e Cornigliano, l’Italsider cede la proprietà dell’acciaieria al gruppo Lucchini ed assume il nome di “Lucchini spa”.
Nel 2003 la Lucchini spa diventa una holding finanziaria e l’impianto viene denominato Lucchini-Piombino spa.
Una serie di crisi e cambi di assetto azionario, nei quali sono stati coinvolti anche i russi di Severstal, portano l’acciaieria al commissariamento in amministrazione controllata. Il 7 Gennaio 2013 il Tribunale di Livorno dichiara lo stato di insolvenza e si va verso il fallimento.
Il 24 Aprile 2014 l’altoforno viene spento! Finisce così una storia durata più di 100 anni!
Nel novembre dello stesso anno, gli algerini di Cevital, con a capo il finanziere Rebrab, acquistano gli asset della Lucchini e nel Luglio del 2015 costituiscono la società Aferpi (acciaieria e ferriere di Piombino). Prospettive di ambientalizzazione dell’impianto affiancato da produzioni agricole; ma nulla si concretizza e nel Maggio del 2018 l’Aferpi è ceduta agli indiani di JSW (Jindal south west) con finanziamento statale di 15 milioni di euro ed un altro dalla Regione di 30 milioni. I dipendenti a tale data risultano 1600. Attualmente l’acciaieria è in stato di crisi con le maestranze in cassa integrazione. Il piano industriale esibito da Jsw prevede l’attivazione di forni elettrici nei quali trattare anche il preridotto, ma gli indiani vogliono che lo Stato finanzi l’opera al 50%.
Lo Stato sta cercando di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione di un impianto siderurgico ed è notizia di questi giorni che ha firmato un protocollo con l’ucraina Metinvest e la Danieli di Buttrio (Friuli). Con tale intesa si avvia uno studio di fattibilità per un’acciaieria “green” con 1500 dipendenti e 3 milioni di tonnellate di acciaio l’anno.
Come si dice: se son rose fioriranno!
(continua...)
Giampaolo Zecchini