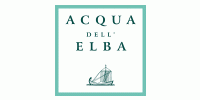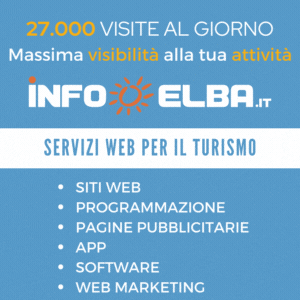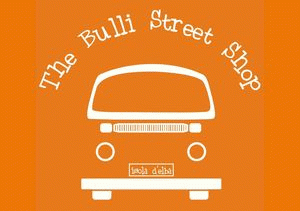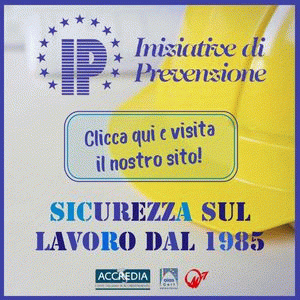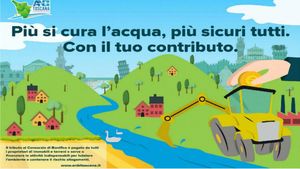Un bellissimo intervento di Ezio Mauro su Repubblica di giovedì 12 dicembre mi induce a proporre alcune riflessioni nel giorno del grande ritrovo romano delle Sardine.
Dice Mauro: “C'era dunque un altro Paese, dietro l'angolo. Disperso, con la fine delle grandi culture politiche, tramontate dopo aver dato un segno al Novecento. Deluso, per la crisi di una rappresentanza sempre più debole, intermittente e a bassa intensità. Silenzioso, davanti al fragore dei populismi che intasavano di rabbia e rancore ogni spazio pubblico. Un Paese scomparso, inabissato, forse sommerso, comunque incapace di pensare se stesso e dunque di dare una forma alla sua esistenza, di esprimere un significato: figuriamoci una politica”; <…> “L'antipolitica infatti ha bisogno di azzerare il patrimonio storico del Paese, cortocircuitando tutta la vicenda repubblicana in una condanna sommaria, per segnare l'Anno Zero del nuovo inizio. Da questo sfondamento della storia, in una cornice radicalmente di destra, inevitabilmente viene avanti un richiamo disarticolato ma insistito al fascismo: visto con benevolenza, blandito, comunque ammesso nel sistema, accolto con l'indulgenza plenaria dai leader che brandiscono il rosario mentre invocano la ruspa contro i dannati della terra”. Questo lo stato dell’arte fino al raduno di Bologna, il 15 novembre 2015.
Cosa è successo a Bologna, e poi in tante altre città d’Italia e fuori? E chi sono le Sardine che hanno inventato il moto ondoso che oggi tocca Roma?
Non credo sia possibile dirlo. Certo non è un Partito né un Movimento come furono i 5 Stelle. Hanno dietro tante storie diverse, tante età diverse, tante culture diverse. Sono proclamati solo alcuni punti fermi: sono repubblicani, antifascisti, non-violenti. Hanno età molto varie -dagli studenti ai pensionati- senza connotazioni di genere, senza storie condizionanti. Non hanno, finora, capi o ideologi; si propongono decisi e gentili; conoscono e utilizzano i social con perizia e misura, e hanno sviluppato rapidamente una capacità organizzativa notevole.
Ma cosa vogliono, cosa vogliono fare, cosa hanno da darci, a chi si rivolgono? Queste domande, che da subito sono state rivolte loro da giornali (di destra, perlopiù) e opinionisti, non hanno trovato risposte se non da parte di chi le poneva: “sono emanazione di questo o quel partito (prevalentemente PD, che si vede gratificato di una capacità attrattiva che sarebbe ben contento di possedere), sono eredi di questo o quel movimento (scomodando il “’68”, che partiva da presupposti -molti- ideologici, da una elaborazione teorica “a monte” -come si diceva- che caratterizzava i diversi rivoli del Movimento), sono contro Salvini e in concorrenza coi 5 Stelle. E credo siano domande e risposte sbagliate alla radice.
Prosegue ancora Mauro: “Se tutto questo diventava giorno dopo giorno senso comune, c'era un unico modo di opporsi: con un'altra rappresentazione del Paese, da cercare dentro la società, in quelle energie civiche disattivate che la politica tradizionale oggi fatica a riconoscere e organizzare. Puntando non a chiedere un voto, ma molto di più, un giudizio, e quindi un'assunzione di responsabilità. Costruendo non un movimento, ma un linguaggio diverso, un pensiero alternativo, addirittura una cultura civile concorrente: tutto ciò che dà forma a una comunità e che si era perduto, lasciando che la destra lo cercasse un'altra volta nel nazionalismo e dunque nella terra, nel sangue, nel colore della pelle”.
Ecco. Non si deve chiedere cosa possono fare questi nuovi protagonisti della scena politica per noi, ma cosa possiamo fare noi -ciascuno di noi, individualmente o come gruppi spontanei o variamente organizzati, persino come partiti o Movimenti- nella nuova scena politica che sembra essersi aperta dal 15 novembre: costruire un linguaggio diverso, un pensiero alternativo, una cultura civile concorrente.
I ragazzi nel mare magnum della Sardine provengono, pare, dal variegato mondo del volontariato, dell’associazionismo giovanile -nel loro “Manifesto” non è difficile rintracciare echi della cultura scoutistica- dei movimenti religiosi di base; e gli endorsement ricevuti da personalità pubbliche di orientamento vario -ancorché definito dal carattere repubblicano, antifascista, legalitario- sembrano offrire qualche luce identificativa. Ma questo è del tutto irrilevante.
Le Sardine hanno ridato cittadinanza a quel “Paese scomparso, inabissato, forse sommerso, comunque incapace di pensare se stesso e dunque di dare una forma alla sua esistenza, di esprimere un significato: figuriamoci una politica”, lo hanno richiamato a una presenza attiva, a un rinnovato protagonismo. Ora da quel Paese si devono far sentire le istanze, diverse ma fondamentalmente omogenee, che ciascuno di noi porta dentro o che comunica solo a pochi intorno a sé: l’idea che coltiva di Libertà, di Eguaglianza, di Solidarietà -per stare sul classico-; di libertà di crescere e esprimere i propri valori, di partecipare delle risorse disponibili, di veder riconosciuto il proprio contributo al benessere di tutti e di avere garanzie per una sussistenza dignitosa, di aver garanzie per una crescita culturale da riversare nel patrimonio comune. Ma queste sono le prime cose che sono venute in mente a me. Unite a quelle che ciascuno di noi potrà elaborare e mettere a disposizione, attraverso un confronto esterno a ogni “rappresentanza estrema”, a ogni “radicalità irrispettosa”, a ogni “mancanza di galateo sociale, culturale e politico”, costruirà quella base ideale e prammatica che oggi il nuovo Movimento non ha ancora espresso. Recuperando “l’orizzonte condiviso delle differenze, il Patto sociale, il Patrimonio storico del Paese”. Cercandolo “dentro la società, in quelle energie civiche disattivate che la politica tradizionale oggi fatica a riconoscere e organizzare”. Affrontando i problemi reali -tantissimi- della nostra società, senza bisogno di far ricorso al senso di insicurezza, di paura, di provvisorietà che solo l’ingiustizia profonda che crea povertà e mancanza di decoro, e non i migranti o gli zingari o i diversi hanno generato. Elaborando nuove strategie di intervento.
Si chiama politica, e ha davanti orizzonti sconfinati. Quello che ha dietro è poco rilevante: “Per raggiungere la meta che non conosci devi prendere la strada che non conosci” (Giovanni della Croce, sec. XVI).
Luigi Totaro