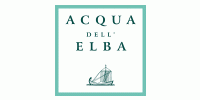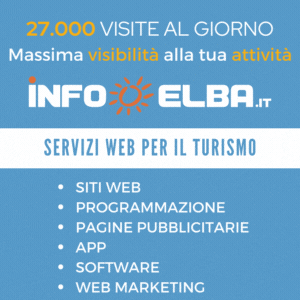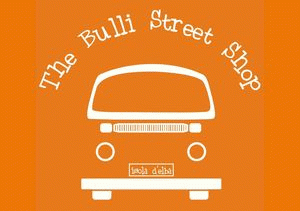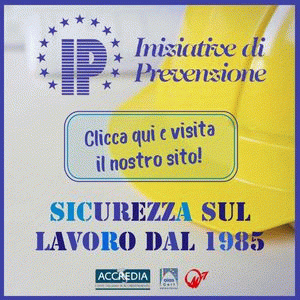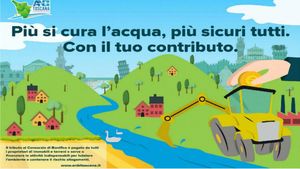In molte occasioni comuni capita di scoprire che ciò che si credeva essere il raggiungimento conclusivo di uno studio, di un’indagine, della ricerca di qualcosa si dimostri essere in realtà solo una piccola parte di un insieme più grande di cui non si sospettava l’esistenza. Un tipico esempio è il risultato di un’indagine di polizia in cui l’arresto del malvivente tanto ricercato porti a scoprire tutto un sistema ben più complesso e articolato di corruzione con ben più numerose persone coinvolte. In questi casi il modo di dire comune riferendosi al primo ritrovamento è senza dubbio: “è solo la punta dell’iceberg”.
Ma perché si dice così ? La ragione è che gli iceberg sono un felice paragone della situazione appena descritta poiché già gli antichi naviganti in acque polari cristalline osservarono che la loro parte emersa è ben più piccola di quella sommersa. In questa pillola di Scienza, oltre a celebrare alcune proprietà che fanno dell’acqua un elemento davvero straordinario, si capirà ‘quanto’ iceberg è sommerso, poiché questa porzione non è casuale, bensì ...una questione di Fisica.
Ma iniziamo dall’acqua, elemento che identifica il pianeta Terra e motivo della stessa vita su di esso. La proprietà più straordinaria dell’acqua è certamente che la sua forma solida, cioè il ghiaccio, è meno densa della sua forma liquida. Ciò non è vero per quasi tutte le altre sostanze, che se solidificano sono più dense e quindi appena lo fanno precipitano sul fondo.
Questa proprietà dell’acqua non sembra particolarmente degna di nota o di attenzione finché non si pensa cosa accadrebbe ad esempio ad un lago alpino se le cose non stessero in questo modo. Infatti se il ghiaccio fosse più denso dell’acqua liquida, pare ovvio che con l’abbassarsi della temperatura ambiente la superficie del lago inizierebbe a ghiacciarsi e lo strato di ghiaccio precipiterebbe sul fondo. In realtà succederebbe una cosa peggiore: il lago inizierebbe a ghiacciarsi partendo dal fondo e, se le basse temperature si protraessero abbastanza a lungo, diventerebbe un blocco di ghiaccio unico uccidendo ogni forma di vita animale e vegetale al proprio interno. L’effetto sulla biodiversità sarebbe devastante e molte specie non solo sarebbero estinte, ma addirittura non avrebbero potuto seguire il percorso evolutivo che le ha portate fino ai nostri giorni.
Per capire la dinamica del congelamento bisogna riferirsi al grafico di densità dell’acqua in funzione della temperatura, visibile in Figura 1:

Figura 1. Grafico della densità dell’acqua dolce per temperature di poco superiori a 0 °C.
Sebbene i valori in ordinata varino solo nei decimali, la curva è nettamente una parabola convessa con massimo corrispondente alla temperatura di circa 4 gradi Celsius (quelli della scala termometrica normalmente utilizzata in Italia). Dunque se l’acqua inizialmente a 0 °C viene riscaldata (si fa per dire :-) ) fino a 4 °C essa subisce una ‘contrazione’, poiché le molecole che prima erano disposte in modo piuttosto largo e comodo nella struttura cristallina del ghiaccio riescono ora ad impacchettarsi le une più vicino alle altre. Questa contrazione fa dunque si che l’acqua liquida a 4 °C sia più densa del ghiaccio a 0 °C. Vediamo dunque gli effetti sulla dinamica del laghetto alpino…
Con l’arrivo dell’inverno l’acqua vicino alla superficie si raffredda passando ad esempio da 10 °C a 6, poi a 5, poi a 4 °C. In questo processo la sua densità aumenta e quindi, man mano che si raffredda, l’acqua della superficie sprofonda verso il basso prendendo il posto di quella più calda (si fa sempre per dire, essendo a 10 °C in questo esempio). Nasce così una sorta di rimescolamento, poiché l’acqua più calda che prima era sul fondo del lago viene spinta verso la superficie dove a sua volta si raffredderà a causa della minore temperatura esterna (vedi Nota in fondo all’articolo).
Continuando il processo, prima o poi tutta l’acqua del lago avrà temperatura uniforme pari a 4 °C e pertanto il rimescolamento cesserà poiché non ci sarà più un sostanziale volume di acqua meno densa da qualche parte. A questo punto ulteriori cali di temperatura esterna comporteranno un conseguente calo della temperatura dell’acqua vicino alla superficie, dove galleggerà fino ed oltre il congelamento. Si forma così il noto strato di ghiaccio superficiale che può raggiungere spessori di decine di centimetri a seconda delle latitudini e delle condizioni termiche:

Figura 2. Lago in cui il foro praticato per un’immersione sub rivela lo spessore dello strato di ghiaccio.
In questo modo il fondo del lago non sarà mai ghiacciato e le alghe, le piante e gli animali al suo interno potranno vivere tranquillamente, essendosi adattati a questo tipo di ambiente nel corso dell’evoluzione. Anche sotto questo punto di vista l’acqua è una sostanza davvero strabiliante.
Dopo aver compreso quindi perché il ghiaccio sta in superficie, possiamo tornare al nostro iceberg e capire più a fondo il suo galleggiamento.
Per il Principio di Archimede un corpo immerso in un fluido subisce una forza dal basso verso l’alto (quindi opposta alla forza di gravità) pari al peso del quantitativo di fluido spostato. È questo il motivo per cui un cubo di ferro di massa 1 kg (che ha lato circa 5 cm) in acqua precipita immediatamente sul fondo, mentre lo stesso chilo di ferro battuto a formare una scodella galleggia tranquillamente: stiamo considerando sempre la stessa massa di ferro, ma nel primo caso essa sposta un irrisorio cubo di acqua di lato 5 cm, nel secondo caso una grande semisfera di acqua la cui massa è ben maggiore di quel chilogrammo di ferro. Nel secondo caso vince pertanto la spinta di Archimede sulla forza peso (che è pari alla massa del corpo moltiplicata per l’accelerazione di gravità):

Figura 3. Una massa di 6 kg immersa in acqua riceve una spinta di Archimede poiché (in questo esempio) sposta una massa di 2 kg di acqua. La sua massa ‘apparente’ è pertanto di soli 4 kg.
Il principio si riferisce tuttavia alle forze, non alle masse, cioè è generale in ogni condizione di gravità. Le forze di questo esempio, sulla Terra, si ricavano moltiplicando i valori indicati delle masse per l’accelerazione di gravità, in media pari a 9.81 m/s2 sulla superficie terrestre.
Il galleggiamento di un corpo si ha quando questi due contributi di forza, la forza peso rivolta verso il basso e la forza di Archimede rivolta verso l’alto, si equiparano compensandosi esattamente a vicenda. Ricordiamo che la massa di un corpo è pari alla sua densità per il suo volume, sicché dire:
forza peso dell’iceberg = forza peso dell’acqua di mare spostata
equivale a scrivere la relazione:

dove V esprime il volume, g = 9.81 m/s2 è l’accelerazione di gravità media sulla superficie terrestre e la lettera greca ρ, che si legge ‘rho’, è la densità del corpo che vale circa 1025 kg/m3 per l’acqua di mare e circa 930 kg/m3 per il ghiaccio della stessa acqua.
Con semplici passaggi possiamo quindi dedurre la frazione di iceberg che rimane sommersa come rapporto fra i due volumi:

che risulta essere pari a:

Ecco dunque che la percentuale di iceberg sommersa è pari a circa il 90.7% dell’intero blocco di ghiaccio. Questo è vero sempre, per qualunque iceberg, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua forma. Come dimostrato, infatti, questa percentuale è legata unicamente al rapporto fra le densità dell’acqua nelle sue sue due forme liquida e solida, il ghiaccio.
La stra-grande maggioranza di massa ghiacciata sta dunque ‘nascosta’ sotto il pelo dell’acqua e, a giustificare il titolo di questo articolo, poco meno del 10% è la parte dell’iceberg che emerge e si rende visibile sopra la superficie del mare ...è davvero solo la punta dell’iceberg.
Nota: è opportuno specificare che la frase “l’acqua si raffredda a causa della minore temperatura esterna” non deve essere mal interpretata. Non è infatti l’aria fredda con cui viene a contatto a raffreddare l’acqua sottostante, bensì l’esatto opposto: è l’acqua che scalda l’aria con cui viene a contatto, perdendo così calore e raffreddandosi. Ciò deriva direttamente dalla direzione del flusso di calore dettata dal Secondo Principio della Termodinamica, secondo cui è sempre il corpo più caldo a cedere calore ad un corpo più freddo con cui viene in contatto e mai il contrario.
Marco Sartore